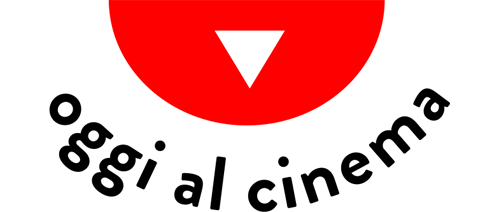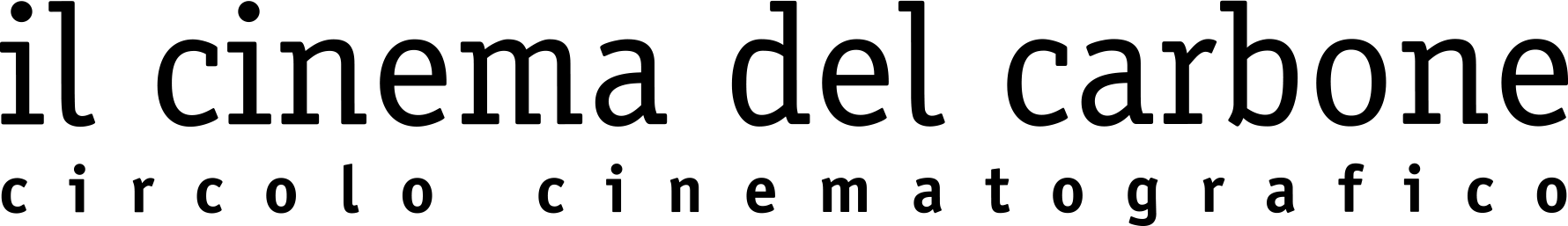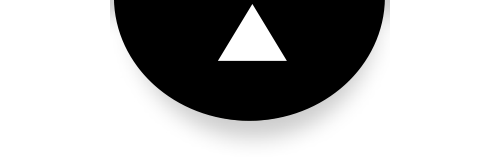Made in Hong Kong
di Fruit Chan — Hong Kong, 1997, 108'
con Sam Lee, Neiky Yim, Wenders Li, Amy Tam, Carol Lam, Doris Chow
proiezione in cinese con sottotitoli in italiano
Moon (Sam Lee) è un teppistello da quattro soldi che ha lasciato la scuola e vive al soldo di un piccolo boss della mala. Predestinato alla caduta, ma ingenuamente alla ricerca di un riscatto, spende il suo tempo inutile e violento con Sylvester, l’amico ritardato, e un giorno s’innamora di Ping, una malata terminale. Quanto basta per innescare, fatalmente, la tempesta perfetta...
Made in Hong Kong è un film capitale, un potentissimo concentrato di alienazione urbana e disperazione giovanile, girato con una totale mancanza di fondi e una freschezza davvero impressionante. Uscito subito dopo l’Handover che, nel 1997, ha riconsegnato Hong Kong alla Cina, il capolavoro di Fruit Chan restituisce pienamente il fervore artistico e il clima sociale della città. Un periodo di rottura e di occasioni per il cinema dell’ex colonia britannica che, dopo i fasti di Bruce Lee e l’onda lunga di John Woo e Wong Kar-wai, ha dovuto necessariamente cercare una rinascita. Sospeso tra realismo e narrazione, tra la crudezza del cinema “da” strada e la poesia del cinema “di” strada, Made in Hong Kong è rimasto invisibile/introvabile per vent’anni, e torna ora a nuova vita grazie al restauro prodotto dal Far East Film Festival.
Made in Hong Kong presuppone fin dal titolo internazionale (traduzione letterale dell’originale cantonese) una rivendicazione, la certi cazione di un’appartenenza geografica, politica, sociale ed economica. L’appartenenza a Hong Kong. Quan-do il film esce nelle sale in patria, grazie all’intuizione di Andy Lau, Shu Kei e Doris Yang, il 9 ottobre del 1997, la città-stato è tornata nelle mani della Cina da una novantina di giorni, dopo cento anni trascorsi sotto il regno britannico. Cosa ne sarà di Hong Kong? L’interrogativo rimbalza da una parte all’altra del globo, e vede impegnati in dissertazioni di vario tipo esperti di politica internazionale: cosa ne sarà di Hong Kong ora che il Regno Unito ripiega le bandiere e avanza la Cina, a riappropriarsi di un territorio piccolo ma indispensabile per il controllo economico e strategico del sud-est asiatico e dell’Estremo Oriente?
Made in Hong Kong si apre con la voce fuori campo di Moon, giovane protagonista della vicenda, che spiega agli spettatori quale sia già il suo destino: ha lasciato la scuola ed è entrato nella piccola criminalità cittadina. «Non ero bravo negli studi, ma il sistema scolastico non è certo migliore di me»; una frase che è già una sentenza, per una vita che, come il film mostrerà senza alcuna reticenza, non ha scampo. Non è prevista via d’uscita alle giovani generazioni di Hong Kong, almeno tra quelle che si agitano nelle classi proletarie e sottoproletarie, che ingrassano il sistema senza averne un granché in cambio. Non è prevista via d’uscita per Moon, Ping e ancor meno per Sylvester, grande e grosso ma non supportato da un’intelligenza altrettanto spiccata. Sono tutti e tre spacciati.
Fruit Chan li riprende mentre si aggirano per la città, alla ricerca di destinatari di lettere insanguinate abbandonate da una loro coetanea che ha deciso di togliersi la vita. Sono come fantasmi. Sono già morti. Se all’epoca in molti scambiarono Made in Hong Kong per l’esordio alla regia di Fruit Chan, sbagliando (prima di lui vengono un paio di lungometraggi), l’errore può essere considerato comprensibile. Di più, lo si può considerare come un’illuminazione. È in effetti da Made in Hong Kong, che Marco Müller portò in anteprima mondiale in concorso al Festival di Locarno nell’agosto del 1997, che è legittimo parlare del “cinema di Fruit Chan”. Sono trascorsi venti anni dall’Handover. Sono trascorsi venti anni da Made in Hong Kong...
Raffaele Meale, www.quinlan.it