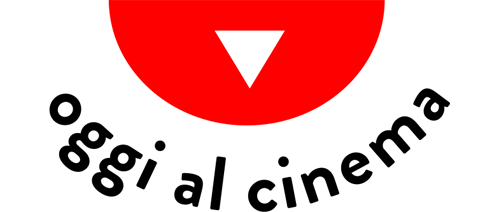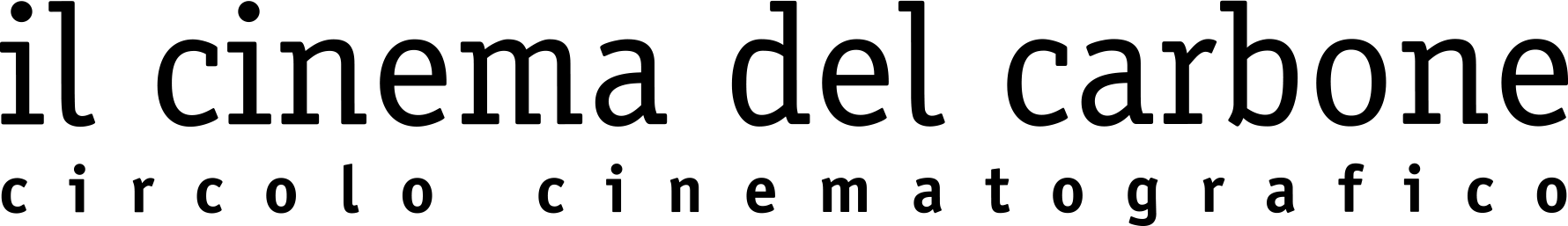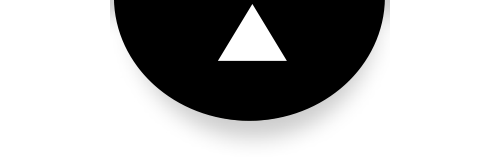10 febbraio 2026
Il ‘Sentimental Value’ delle case che abitiamo
Ogni tanto la nonna elenca in modo malinconico i mobili della sua vecchia casa. Se mia madre è nei paraggi, segue il solito battibecco, Perché li hai dati via allora, se poi devi farmi una testa così?
Non pensavo li volessi.
Ti ho mai detto questo?
In ogni caso, è andata come è andata.
Gli antropologi di Ayşegül Savaş è un bel romanzo ora molto di moda che racconta di una coppia di fuori sede in una città imprecisata alla ricerca di una casa. La casa è, ovviamente, metafora di molte più cose, e di cose grandi e piccole è pieno il libro. Vasetti comprati al mercatino delle pulci, spezie per insaporire piatti che ricordano posti lontani, lampade, giacche, libri, fogli di giornale. E quei mobili della nonna perduti, forse finiti in altri mercatini. Tutto ciò che compone le nostre vite piccole che vogliamo credere grandi perché sappiamo come arredarle.
Su una casa si apre Sentimental Value, il magnifico film di Joachim Trier candidato ieri a nove Oscar. È una casa che vive e che muore. Che scricchiola e che si rompe. Che accoglie risate, baruffe, nascite, addii. È una casa dove, di tanto in tanto, qualcuno torna a riprendere qualcosa che aveva lasciato: anche qui un vaso, o le casse di un vecchio stereo.
Ma, soprattutto, in quella casa si vanno a riprendere le persone lasciate indietro, che lo vogliano o no. In quel villino di legno rosso nel centro di Oslo il papà regista (Stellan Skarsgård) immagina, dopo tanti anni, un nuovo film solo perché le figlie – una attrice (Renate Reinsve) che lui vorrebbe finalmente dirigere, l’altra archivista (Inga Ibsdotter Lilleaas) che va a cercare in altri oggetti, foto, diari, registri, i segreti di famiglia – possano credere ancora nella vita di quella famiglia. La messa in scena serve, forse, a svelare la realtà.
Trier e il suo sceneggiatore Eskil Vogt sono antropologi per davvero, e da sempre (Reprise, Oslo, 31. august, Thelma, La persona peggiore del mondo) usano quelli che apparentemente sono dettagli – ninnoli, soprammobili, accessori psicologici ed esistenziali – per costruire un mondo: il loro, il nostro. E così il cinema di Trier è diventato una casa da abitare, e che riconosciamo di film in film anche se cambiano gli ospiti, e la disposizione dei mobili, e la luce entra in modo diverso – e, a un certo punto, comunque ti acceca.
Anche qui che sembra tutto scuro. Ci sono un padre e una figlia, in particolare, che non si parlano più. Una scia di litigi, abbandoni, tentati suicidi, funerali. Tutto in quella casa che cambia – la vediamo dall’inizio del secolo a oggi, attraverso una voce narrante che sembra quella della casa stessa – e che resta a testimoniare l’immutabile storia di quella famiglia, di tutte le famiglie.
Trier ha – letteralmente – costruito una casa che sta dentro la sua (e la nostra) casa più grande, che è il cinema. Ingmar Bergman è una sua ispirazione inevitabile da sempre, e qui ancora di più. Perché il film – e il blackout di Nora (nomen omen), il personaggio di Reinsve – inizia dal teatro. Per quei volti sovrapposti dal montaggio che sono un esplicito rimando a Persona, come a sgomberare il campo da eventuali “hai copiato!”: ve lo dice lui per primo. Per un certo spiritismo che anima le storie dei vivi e dei morti, che si confondono continuamente. Per quel che è lecito mischiare – e rubare, divorare, violare – tra arte e vita che è parte di tantissimo cinema di Bergman, da Il posto delle fragole a Sinfonia d’autunno, e anche della sua vita stessa. L’altra sera sul palco degli EFA, i cosiddetti Oscar europei, c’era Renate Reinsve accanto a Liv Ullmann, e sembrava che il tempo si fosse fermato, che fossero parte di un unico film, abitanti della stessa casa nello stesso momento.
Ma Sentimental Value sono anche altre case cinematografiche in senso letterale. Il design porn inconsapevole di certi appartamenti parigini (o delle maison di campagna) di Rohmer. O le famiglie divise e riunite dietro le pareti di carta di riso di Ozu. O gli appartamenti newyorkesi di Woody Allen: anche in questo villino norvegese, dopotutto, si possono ascoltare di nascosto le confessioni dei pazienti della mamma psicanalista, attraverso la stufa che comunica con la stanza accanto.
Joachim Trier è da sempre un regista classico, ma mai nostalgico. Ha l’occhio sul presente e la sua umanità de-generata (vedi La persona peggiore del mondo), e anche se in Sentimental Value si affida a luoghi che sono simbolicamente e volutamente analogici – il palcoscenico, una biblioteca, un’idea di cinema che è appunto novecentesca (con tanto di sberleffo all’ossessione per i moodboard e ai registi passati su TikTok) – non si avverte mai il peso del passatismo.
Nemmeno nel finale. C’è quello che riguarda i vari personaggi e i loro prodigiosi interpreti – il padre, le sorelle, l’attrice americana (Elle Fanning) arrivata su quel set finto/vero, e tutti i fantasmi del passato – e c’è quello che riguarda la casa in cui questa storia è ambientata. Ed è, tra tutti, il più straziante. Non vi dico come diventa quella casa – che abbiamo visto affollata, sgangherata, disordinata, in una parola: abitata – alla fine di Sentimental Value. Se è più bella all’inizio o alla fine. Se dentro ci sono ancora i mobili della nonna. È solo una questione di valore affettivo, che è la cosa, nella gioia e nel dolore, a cui questo film chiede di non abdicare mai.
Mattia Carzaniga, RollingStone

09 febbraio 2026
Pillion: un viaggio lucido, divertente e bellissimo in un sottobosco della comunità omosessuale non troppo raccontato
Pillion - Amore senza freni, il nuovo film di Harry Lighton al cinema dal 12 febbraio, è di una bellezza e di un'intensità disarmanti, perché non solo racconta l'incontro di due ragazzi diversissimi per temperamento e atteggiamento, ma anche un tema molto poco frequentato e ancora intasato di tabù come il sesso come dominazione e controllo.
Il film, presentato in anteprima a Cannes dove ha vinto il premio Un Certain Regard per la migliore sceneggiatura, ha come protagonista Harry Melling che tutti ricorderete come il cugino Dudley nella saga di Harry Potter: qui lo ritroviamo più magro, meno spilungone e decisamente più impaurito, deciso a condurre una vita alquanto passiva in un’anonima città del Regno Unito dove vive insieme ai genitori. Le cose cambiano quando Colin, questo il nome del suo personaggio, ancora tristemente incerto sul posto che occupa nell’ecosistema gay, incontra al bar un uomo avvenente e sicuro di sé che non passa certo inosservato. Con grande sorpresa di Colin l’uomo - come scopriremo in seguito, un appassionato di motociclette di nome Ray, interpretato da Alexander Skarsgård - si avvicina e, sorprendentemente, gli passa un biglietto con un messaggio stringato che gli indica dove e quando incontrarlo la sera successiva, ovvero il giorno di Natale. Inizia, così, una specie di improbabile storia d’amore, o corteggiamento, o accordo contrattuale che vede Ray e Colin in due posizioni opposte, il primo come dominatore e il secondo come dominato considerando che, per far sì che la relazione funzioni, Colin fa tutto quel che gli viene detto, impaziente di accondiscendere agli ordini di questo adone autoritario le cui istruzioni burbere e impassibili sono al tempo stesso eccitanti e minacciose.
Mentre i genitori di Colin, la madre malata (Lesley Sharp) e il padre incoraggiante (Douglas Hodge), sono sempre più confusi man mano che Colin si sottomette a questo misterioso motociclista al punto da cambiare abbigliamento, aspetto e comportamento, Colin inizia a volere di più, cominciando a guardare Ray non solo con gli occhi di un dominato in perenne adorazione ma anche di un ragazzo che sogna di essere amato. Sospendendo miracolosamente ogni giudizio su quello che vediamo sulla scena, Pillion non getta alcuno sguardo pruriginoso o minaccioso su una sottocultura come quella delle pratiche sessuali non convenzionali, scegliendo un approccio più riflessivo e compassionevole, che non edulcora né ignora la vera natura della relazione tra Colin e Ray. Pur essendo per certi versi esplicito, il film è di un'onestà e di una franchezza sconcertanti anche solo perché mette sul tavolo una domanda fondamentale: quand’è che una cessione dell’autonomia concordata volontariamente smette di essere del tutto consensuale? Attraverso una comicità sottile - si sorride molto in Pillion - e una lucida rappresentazione di certe norme culturali e sociali di una certa comunità gay - motociclisti, leather daddy e rispettivi partner - questo film è anche profondamente intimo e raffinato perché racconta non solo il percorso di formazione e di cresciuta di un ragazzo, Colin, alle prese ora con l'inquietudine e ora con l'euforia, ma ancora cosa voglia dire per un dominatore severo e trattenuto come Skarsgård tradire la sua natura e lasciarsi andare, suggerendo che dietro il personaggio iper-mascolino e dominatore affondino le radici in un’omofobia latente e autodistruttiva.
Mario Manca, Vanity Fair

03 febbraio 2026
L’autobiografia atipica di Amélie Nothomb in una coloratissima e poetica fiaba d’animazione: La piccola Amélie
“Un nulla che occupa spazio”, “un ortaggio”. Immobile, e onnipotente. Probabilmente è questa la sensazione che prova ogni essere umano nei suoi primi giorni di vita. La stessa che prova la piccola Amélie, narratrice in soggettiva di questo bel film d’animazione diretto da Mailys Vallade e Liane-Cho Han, tratto dal bestseller Metafisica dei tubi di Amélie Nothomb (Voland Edizioni), testo che a sua volta era un’autobiografia sui generis della scrittrice belga, nata nel 1967 a Kobe, in Giappone, da genitori diplomatici.
Ecco dunque che l’opera d’esordio come sceneggiatori e registi di Mailys Vallade e Liane-Cho Han (entrambi con un lungo lavoro di animatori alle spalle) mantiene accesa la fiamma di questo magico viaggio nella dimensione della prima infanzia, restituendone i vividi colori delle scoperte e l’inafferrabile sensazione relativa ai misteri più profondi che, giocoforza, accompagnano un’intera esistenza.
Il morso scatenante, quello che compiuti i due anni la apre definitivamente al mondo (di fatto svegliandola da quella “venerata” apatia) è quello ad una tavoletta di cioccolato bianco che le porta la nonna dal Belgio: la curiosità di Amélie nei confronti della vita esplode, il film ne asseconda in maniera caleidoscopica le innumerevoli emozioni, ne attende – proprio come i genitori e i due fratellini più grandi – la prima parola, la segue poeticamente tra le meraviglie e le insidie di quel bellissimo giardino antistante la casa.
Centrale diventa poco a poco il rapporto tra la bimba e Nishio-san, la giovane tata: è attraverso questo legame, unico e profondo, che tale fiaba di (prima) formazione, sarcastica e a suo modo irriverente, riesce a insidiarsi al di qua dello sguardo (che è di per sé “una scelta, dato che soffermarsi su qualcosa di determinato comporta un’esclusione, un rifiuto”. E “vivere vuol dire rifiutare. Chi accetta ogni cosa non è più vivo dell'orifizio di un lavandino”…), senza ricorrere a facili didascalismi (l’anziana padrona di casa giapponese che non gradisce che la bambina, per lei “straniera”, venga coinvolta nei tradizionali rituali locali), esaltando con delicata naturalezza la magia nascosta dei gesti più semplici. E ragionando sul senso profondo del doversi muovere tra due mondi (quello d’origine, quello di crescita), facendo i conti non solo con le scoperte più elettrizzanti, ma anche con il dolore (la morte), con le ferite che possono essere lasciate da qualsiasi esperienza sulle cose. Proprio perché, appunto, solamente nei tubi le cose passano senza lasciare tracce.
Candidato come miglior film d’animazione ai prossimi Oscar, La piccola Amélie ha vinto il premio del pubblico all’Annecy International Film Festival, il premio per il miglior film europeo al San Sebastián Film Festival, è stato presentato al Festival di Cannes ed ha ottenuto una menzione speciale ad Alice nella Città
Valerio Sammarco, Cinematografo

26 gennaio 2026
La scomparsa di Josef Mengele ci regala il vero volto del male
Tratto dalla biografia di Olivier Guez, uscita nel 2017, “La scomparsa di Josef Mengele” fin dall'inizio si calibra come un racconto cinematografico completamente atipico, sia dal punto di vista estetico che narrativo. Serebrennikov decide di alternare passato e presente, di seguire l'invecchiamento di Josef Mengele, il suo vagare eterno e allucinato tra Brasile, Argentina, Paraguay, che a poco a poco lo spinge quasi alla follia. La straordinaria fotografia di Vladislav Opelyants alterna un bianco e nero elegante, freddo, con il colore, usato però abbastanza sporadicamente e soprattutto sempre in contesti e momenti molto precisi. La sua regia è dinamica, stretta, segue come un segugio i passi di un uomo tra i più contorti, inquietanti, odiosi e spezzati che si siano mai visti. “La scomparsa di Josef Mengele” ce lo mostra nell'Argentina seconda patria dei nazisti, tra svastiche, celebrazioni bellicose, matrimoni combinati e ricchezza. Poi però ecco che Israele comincia a dare la caccia ai gerarchi impuniti, e Josef è costretto, da facoltoso medico, a spostarsi cambiando pseudonimo, finendo dentro un gorgo asfissiante, sempre nel terrore che chiunque sia un nemico, che la punizione arrivi.
Ma chi era Josef Mengele? Se lo chiede lo spettatore, desiderando andare oltre i cliché, ma se lo chiede anche Rolf (Maximilian Meyer-Bretschneider) il figlio che lo va trovare quando ormai è sempre più vicino alla demenza, perso nei suoi sproloqui autoassolutori, nella giustificazione degli orrori che ha commesso, nell'idea che chiunque, fuori da quella catapecchia in cui vive come uno scarafaggio, sia comunista o ebreo. Non può che venire alla mente “La zona d'interesse” di Jonathan Glazer, altro film straordinario e opprimente, altro sguardo dell'orrore dal punto di vista del carnefice. Benché diverse, le due opere sono accomunate dal farci arrivare tutta la banalità, tutta la vuota arroganza, di due omuncoli incaricati di infliggere sofferenze, elevati oltre le loro possibilità da un sistema marcio, un culto sado-maso-mortuario che Serebrennikov ci mostra in più di una sequenza al limite dell'orrore, davvero difficile da reggere. Ma questa era la verità, su Mengele, sulla Germania Nazista, su ogni totalitarismo ideologico che in quanto vuoto assordante, era usato da ognuno per riempirlo con tutto ciò che voleva, nel modo in cui voleva. Mengele lo riempì con sadismo, crudeltà, narcisismo e una fede incrollabile nell'essere parte di un disegno grandioso e necessario.
August Diehl ci regala un'interpretazione incredibile, magnifica e magnetica. Il suo Mengele è il nazismo fatto e finito, ma soprattutto è autentico, inquietante nelle sue adamantine opinioni fuori dal tempo e dalla Storia. Un lavoro eccezionale col trucco ce lo fa vedere giovane e poi nelle varie stagioni dell'anzianità e la cosa più assurda, è che a un certo punto quasi (quasi) proviamo pena per lui. In Argentina era ricco, circondato dai sopravvissuti del Reich. Già lì però si sente assediato, il Mossad è sulle sue tracce, chiunque potrebbe venderlo. Viene protetto per anni da una rete compiacente, che si dirada poco a poco, mentre lui diventa sempre più misantropo, intrattabile, acido e collerico. Ma poi eccoli lì, alienato in una baracca brasiliana, col figlio che lo viene a trovare e non sa cosa dire, come interfacciarsi con quel padre assassino e torturatore, che rifiuta ogni colpa, rivendica l'orrore come merito. Sempre più povero, sempre più solo, infine sempre più assediato dall'Alzheimer, da una paura irrazionale. No, Josef Mengele non l'ha fatta così franca, pare dirci Serebrennikov, la sua condanna è stata vivere solo, senza amore, nella paura, fino alla fine dei suoi giorni.
“La scomparsa di Josef Mengele” è [...] un film necessario, politicamente attualissimo, nel ricordarci che l'orrore è sempre dietro l'angolo. Soprattutto, ci ricorda l'importanza della giustizia, quanto vaghe amnistie o peggio ancora principi di real politik in nome della Guerra Fredda, abbiano permesso il sopravvivere di orrori impuniti, e quindi la possibilità di una loro reiterazione. Prendendosi la licenza di unire fantasia e realtà, ma sempre secondo una logica di approfondimento del personaggio e dei suoi pensieri, “La scomparsa di Josef Mengele” è più che un biopic tour court, una seduta di analisi con cui cercare di farci comprendere il male assoluto, la sua evoluzione, il suo volto, la banalità dentro le tenebre.
Giulio Zoppello, Today

19 gennaio 2026
Sorry, Baby: il ritratto dell’essere donna che il cinema aspettava
Ci sono film che ti introducono alla storia, che ti spiegano cosa stai per vedere. E poi ci sono film che ti chiedono una cosa molto più difficile: fiducia.
Sorry, Baby non ti dice tutto subito. Non ti prende per mano. Entra piano e ti chiede di restare anche quando non capisci ancora perché qualcosa fa così male. È un film che si concede il tempo dell’attesa, del silenzio, della fatica. E proprio per questo, quando finalmente ti rendi conto di cosa stai guardando, è già troppo tardi per restarne fuori.
Scritto, diretto e interpretato da Eva Victor, Sorry, Baby arriva al cinema con I Wonder Pictures e si impone come uno degli esordi più delicati e consapevoli degli ultimi anni. Un film che rifiuta l’urgenza di spiegare, di mostrare, di chiarire subito. E che proprio in questa sottrazione trova la sua forza più profonda.
La storia segue Agnes, giovane professoressa di letteratura, attraverso frammenti di quotidianità: lezioni, amicizie, incontri, piccoli gesti che sembrano normali e che invece portano addosso un peso invisibile. All’inizio non sai davvero cosa le sia successo. Lo intuisci. Lo senti. Ma il film non te lo consegna. Lo lascia emergere con fatica, più avanti, senza mai trasformarlo nel centro spettacolare del racconto.
La natura della ferita – una violenza – viene compresa solo dopo, con estrema cautela. Sorry, Baby non ci fa mai entrare davvero “dentro” quell’evento. E non per mancanza di coraggio, ma per una scelta precisa, quasi etica: non raccontare ciò che è accaduto, ma ciò che resta. Il modo in cui il dolore si deposita nel corpo, nella mente, nelle relazioni. Il modo in cui convive con la vita, senza mai coincidere del tutto con essa.
La struttura a capitoli accompagna questo percorso irregolare. Il tempo non è lineare, la guarigione nemmeno. Ci sono momenti di apparente serenità e improvvise ricadute. Risate che arrivano quando non dovrebbero, silenzi che parlano più delle parole. È un racconto che somiglia alla vita vera, non alla sua versione ordinata e rassicurante.
Eva Victor costruisce Agnes lontanissima da qualsiasi idea di “vittima perfetta”. È ironica, spigolosa, impulsiva. A volte è sgradevole, a volte tenerissima. Ride, si arrabbia, pensa cose che non si dicono. Non viene mai addomesticata per risultare più comprensibile allo spettatore. Ed è qui che il film diventa, in modo sorprendentemente potente, un ritratto dell’essere donna – e dell’essere umana: contraddittorio, fragile, dolorosamente vero.
Accanto a lei, Naomi Ackie è straordinaria nel ruolo di Lydie, l’amica che salva non con grandi discorsi ma con la presenza. Quella che resta, che ascolta, che condivide un linguaggio fatto di sguardi, ironia e complicità. Lucas Hedges porta in scena una gentilezza timida, mentre ogni relazione sembra muoversi con lo stesso rispetto che il film chiede a chi guarda.
In questo universo fatto di ferite e resistenze, c’è anche una tenerezza improvvisa e disarmante: quella di un gatto trovato, accolto quasi per caso, che diventa lentamente parte della famiglia. Un dettaglio apparentemente piccolo, ma centrale. Perché racconta la cura che nasce senza proclami, l’amore che arriva quando non lo stai cercando, la possibilità – delicatissima – di legarsi di nuovo a qualcosa di vivo.
È la stessa logica che attraversa tutto il film, anche nel suo uso dell’umorismo. Sorry, Baby ti fa ridere e, subito dopo, senza avvisare, ti stringe lo stomaco. Per me è stato esattamente questo: una carezza capace di far sorridere e, insieme, togliere il fiato. Un umorismo che non serve a sdrammatizzare, ma a sopravvivere. Che smaschera l’ipocrisia delle istituzioni, la freddezza dei sistemi, le solidarietà di facciata. Non consola ma protegge e permette di respirare quando manca l’aria.
Il film si chiude senza spiegare, senza sottolineare, lasciando spazio a un messaggio chiarissimo proprio perché non viene dichiarato: la forza della vicinanza. L’idea che esserci, restare, accompagnarsi possa essere già una forma di salvezza. Per me è davvero importante che esistano film come Sorry, Baby. Film che raccontano l’essere donna – e l’essere umana – senza semplificare, senza violare, senza pretendere di spiegare tutto. Film che si avvicinano con rispetto e che sanno entrare nelle storie senza fare rumore.
Quando esci dalla sala, Sorry, Baby non ti lascia risposte chiare. Ti lascia una sensazione potente addosso. Ed è così che capisci che il cinema, quando è davvero necessario, sa ancora fare questo: entrare piano e restare.
Sara Scarsella, The Hot Corn

07 gennaio 2026
Ultimo schiaffo, una commedia “natalizia” amarognola che si muove nei territori del noir
Si era lasciato il cinema del regista friulano con la mesta dolcezza di Zoran, il mio nipote scemo, e il sogno di improvvida ricchezza dell’alcolizzato Paolo Bressan – che intendeva sfruttare economicamente le eccezionali doti dell’introverso nipote Zoran Spacapan alle freccette – che si riconduceva in direzione di un ritrovato senso dell’esistere, e lo si ritrova adesso tra i monti friulani innevati, nel paesino minerario sperduto e perdente in cui Petra e Jure cercano in ogni modo di sbarcare il lunario: sono sorella e fratello, decisa ad abbandonare quel luogo lei (ma solo insieme all’amato germano) e meno ancorato al reale, più “semplice” lui, che in qualche modo pare una versione aggiornata e corretta di Zoran. L’occasione per racimolare qualche migliaia di euro e cambiare vita – nonostante una madre affetta da demenza senile, che pensa che la figlia sia morta anche quando si trova davanti a lei – potrebbe giungere dalla scomparsa di Marlowe, un cagnolino dal nome altisonante smarrito dalla signora Ines. Questo evento però finisce con lo scoperchiare un nido di vipere, o per meglio dire la mediocrità di un paese molto più sfaldato di quanto si possa pensare.
Nonostante l’ambientazione natalizia Ultimo schiaffo è un’opera che progressivamente abbandona il campo della commedia per scivolare nei territori del noir, sprofondando nell’ombra oscura che tutto attanaglia, a partire da personaggi già sconfitti dalla vita che cercando disperatamente, con le unghie e con i denti, una redenzione o una riscossa che non è detto però possa esser loro concessa. È questa amarezza il punto di forza di una scrittura che ogni tanto sul crinale della commedia si affida alla battuta più facile ma che trova riscatto proprio nella convinzione che l’umanità sia da ricercare anche e soprattutto là dove il sole non riscalda con i suoi raggi, come avrebbe cantato Fabrizio De André. Ne viene fuori un lavoro anche livido, ma che ha nella scrittura dei personaggi la chiave di volta per tentare un’ultima risalita, un ultimo schiaffo in faccia a una vita insolente, barbarica, in fin dei conti profondamente ingiusta. Il cuore pulsante della vicenda sono ovviamente Petra e Jure, e le interpretazioni sorprendenti di Adalgisa Manfrida e Massimiliano Motta aiutano lo spettatore ad accorarsi a questa storia che sembra trovare uno sposalizio ideale tra i derelitti di Aki Kaurismäki e il grottesco di Teemu Nikki: si resta dunque in territori nordici, come dopotutto l’ambientazione suggerisce, con la neve candida che può facilmente macchiarsi di sangue e Babbo Natale che non è esattamente il portatore di doni. Il calore non lo si può qui trovare sotto il vischio o davanti al fuoco di un camino che non c’è – i due protagonisti vivono in una roulotte e faticano a mettere insieme il pranzo con la cena –, ma solo in questi esseri umani che si dibattono per ottenere quella dignità che non è stata loro concessa. Oleotto e il suo team di sceneggiatori (Pier Paolo Piciarelli e Salvatore De Mola) riescono a muoversi con una certa leggerezza tra i generi, e così Ultimo schiaffo riesce nel suo intento, quello di un cinema medio che sappia ancora raccontare l’umano senza per questo affidarsi alla più frusta retorica, e senza mai dimenticare per strada l’aggettivo popolare.
Raffaele Meale, Quinlan

07 gennaio 2026
La villa portoghese: un piacevole racconto morale sugli imprevisti della vita
Avelina Prat, originaria di Valencia, ha lasciato anni fa l'architettura per il cinema, e la possibilità di cambiare il proprio destino, per ragioni che possono venire dall'esterno o dall'interno, è al centro del suo secondo film, La villa portoghese. Al centro del suo film c'è anche l'importanza di trovare un luogo speciale, da poter chiamare casa (l'architettura ha evidentemente piantato dei semi, che continuano a fruttare su un altro terreno).
Per la moglie di Fernando, così come per il vero Manuel, un posto vale un altro: lo sradicamento è diventato un modo di vivere, dettato da un trauma o percepito come sinonimo di libertà. Non è così per Fernando, magnificamente interpretato da Manolo Solo, il quale dovrà fare, però, un lungo giro per arrivare alla meta, e accettare che il proprio posto possa trovarsi molto lontano rispetto a quanto ha sempre creduto. Quando spiega alla sua classe, all'inizio del film, che il modo migliore per conoscere il mondo è disegnarlo (di nuovo, riga, matita e squadre: gli strumenti dell'architettura) e una studentessa gli chiede se non sia meglio invece percorrerlo realmente, viaggiando fisicamente attraverso le terra che sta illustrando sulla cartina, lui non le dà ascolto, ma è esattamente ciò che gli capiterà di esperire da lì a poco e che gli insegnerà la frequentazione dell'enigmatica Amalia interpretata da Maria de Medeiros.
Prat non teme di puntellare questo racconto realistico di colpi di scena incredibili, che servono il tema della morte apparente e della rinascita, così come fa il lavoro di giardinaggio che Manuel/Fernando impara a svolgere; ma gli avvenimenti inverosimili servono anche l'idea che la vita possa sorprendere continuamente, alternando dramma e commedia sentimentale, e rivelandosi così più cinematografica che mai. Un cinema umano e umanista, dunque, quello di Prat, che ragiona attorno al concetto di famiglia acquisita in termini non stereotipati e invita a pensare l'esistenza come passibile di una continua riscrittura.
Marianna Cappi, Mymovies

16 dicembre 2025
Una battaglia dopo l’altra è il film dell’anno, anzi, forse del decennio
Paul Thomas Anderson firma un’opera incendiaria e irresistibile: tra rivoluzione e melodramma familiare, satira e tragedia, un film che spaventa e diverte, galvanizza e disarma. E trasforma il caos del presente in Cinema puro (feat. DiCaprio, Penn, del Toro e Taylor)
Ci sono tante, troppe cose da dire sul film dell’anno, anzi, probabilmente il film del decennio. Provo ad andare in ordine sparso: uno dei nomi più belli di sempre, Perfidia Beverly Hills (forse nom de guerre, ma certamente memorabile come il personaggio di Teyana Taylor); Leonardo DiCaprio in look total Drugo che urla “¡Viva la Revolución!” con il pugno alzato a Benicio del Toro alias un sensei messicano (!), fixer per quella stessa revolución; un’organizzazione segreta di nazionalisti bianchi che si chiama Christmas Adventurers Club (!); almeno un paio di erezioni a favore di camera di Sean Penn in modalità G.I. Joe alt-right quasi chapliniano; suore fiancheggiatrici dei rivoluzionari che coltivano (e fumano) marijuana; un finale (no spoiler) cla-mo-ro-so à la Punto zero, ma come se fosse stato girato da Antonioni (cit. Variety).
Ok, posso riprendere fiato, che è quello che non ho fatto (sì, è un’iperbole, but still) per tutti i 162 minuti di Una battaglia dopo l’altra. Un’invenzione cinematografica paulthomasandersoniana dopo l’altra, un grido di battaglia (pardon) d’auteur, una chiamata alle armi (“La violenza rivoluzionaria è l’unica via”, dice Perfidia) pacifica (?) capace di usare il Cinema per mettere in scena e far detonare le contraddizioni del nostro tempo. Il punto di partenza è il romanzo Vineland di Thomas Pynchon (e non è il primo adattamento by PTA, vedi Vizio di forma), certo, ma non c’è nessun riferimento storico reaganiano, siamo in un presente sospeso che ricorda in modo angosciantissimo l’America di oggi.
“Make it big, make it bright”, raccomanda Perfidia al compagno di vita e d’armi, Ghetto Pat, aka Rocketman, e cioè DiCaprio (#tuttovero). Specialista in bombe e cotillon, guida insieme a lei i French 75, guerriglieri improvvisati e autoproclamatisi combattenti per la libertà che vogliono sovvertire il regime con azioni casuali. Il loro obiettivo: un centro di detenzione per immigrati a San Diego, sperando che sia il primo boom di una rivoluzione.
E “make it big, make it bright” è quello che fa anche Paul Thomas Anderson in questi primi 10 minuti, che poi diventano 20, 30, 40… insomma, avete capito. Entering il colonnello militare Steven J. Lockjaw di Sean Penn con undercut neo-nazi ed espressione di disgusto perenne, responsabile del centro e caricatura vivente del macho suprematista. Ha un debole per Perfidia, che Anderson scolpisce come ribelle nella ribellione, erede di una lunga stirpe di barricaderi neri, amante, miccia politica, incarnazione di una femminilità bellica e senza compromessi: “La fica è per la guerra, è un’arma”. Una frase che è già slogan, disturbante e profetico, che sintetizza corpo e rivoluzione, sesso e violenza, amore e distruzione. Tra Perfidia, Lockjaw e Pat nasce così un triangolo amoroso tra fazioni politiche che più opposte, e più inquietantemente e pericolosamente intrecciate, non potrebbero essere: “Le rivoluzioni iniziano sempre per combattere dei demoni, poi succede che quei demoni combattano loro stessi”, altra cit., altra profezia. Intanto quella stessa rivoluzione donchisciottesca non russa, e continua a colpire tra attentati e rapine in banca: PTA li segue senza giudizio, in un ritmo che cresce fino all’inevitabile esplosione. Ok, è il momento di fare tutti quanti un bel respiro.
E quando pensi che la traiettoria sia segnata, Anderson rimescola le carte e porta la storia altrove. All’improvviso il film diventa anche un dramma familiare, tenero e devastante: perché il politico è personale, e il personale non è mai stato così politico. DiCaprio è vulnerabilità nel caos, scalda la parte forse più cerebrale del film, pare quasi liberato da una comicità e uno sconvolgimento che lo umanizzano. È l’omaggio del regista (che ha ben tre figlie, e si sente) a un padre imperfetto che cerca disperatamente di non trasmettere il fallimento a chi viene dopo di lui. Il momento in cui non ricorda la risposta in codice alla domanda “Che ore sono?” (nessuno spoiler, è nel trailer) per comunicare con gli amici ribelli è già cult: un dettaglio comico che diventa critica feroce al linguaggio sterile di un certo liberalismo incapace di parlare a chi vorrebbe difendere.
Dall’altra parte della barricata, Sean Penn incarna una satira agghiacciante e insieme irresistibile dell’action man razzista e misogino: un gioco di rimandi e deformazioni che tocca l’apice della sua carriera e lo fa entrare per direttissima nella galleria dei personaggi indimenticabili di Paul Thomas Anderson. Il suo colonnello Lockjaw è al tempo stesso parodia e minaccia, clown tragico e mostro politico. E poi Benicio (basta il nome), che Anderson immagina come un santo protettore di migranti, braccio armato e spirituale di una rivoluzione che forse non è mai davvero cominciata. L’uomo che conosce il confine con il Messico e i suoi segreti, che ha visto troppa violenza per credere ancora nella purezza di una causa. Del Toro si muove lento, parla poco, osserva tutto: un personaggio da antologia, costruito più sui silenzi che sulle parole.
E proprio dai silenzi parte Jonny Greenwood, per riempirli o spezzarli: archi che graffiano, chitarre che esplodono, vuoti improvvisi che diventano assordanti, o una singola, insistente nota di pianoforte che restituisce tutta la tensione, narrativa e umana. Greenwood non accompagna: scrive a sua volta battaglie interiori, un controcanto che amplifica ogni gesto, ogni urlo, ogni smorfia dei protagonisti.
Una battaglia dopo l’altra spaventa e diverte, galvanizza e disarma. Ha fatto impazzire Spielberg, che l’ha visto tre volte e l’ha paragonato al Dottor Stranamore: “Arrivi a un punto dove vuoi ridere, perché se non ti metti a ridere inizi ad urlare”, ha detto. “È tutto troppo reale”. Troppo vicino, troppo adesso. È un nuovo classico: un film d’Autore che diventa un blockbuster ineluttabile. È il lavoro di un Cineasta al massimo della forma, capace di raccogliere il delirio dell’attualità e di farne – lo dico? Sì, lo dico – un capolavoro contemporaneo.
Politicamente affilato senza mai essere moralista, Anderson costruisce un racconto ricco di azione che una volta ingranata la marcia non si ferma più, e che sa alternare l’epica incendiaria a momenti di comicità folgorante. È un film che ha la forza delle proprie convinzioni: ride, sì, ma ride con i denti stretti, perché dietro la risata c’è la vertigine dell’analisi spietata sugli Stati Uniti che non sono mai stati tanto sull’orlo del collasso. Eppure PTA non cede mai alla tentazione del pamphlet: i suoi personaggi restano al centro, con le loro fragilità, i loro fallimenti, le loro ombre. La rivoluzione resta sempre e comunque un fatto umano, prima che politico.
E proprio per questo Una battaglia dopo l’altra è forse il film più radicale della sua filmografia: se Il petroliere era una tragedia americana, se The Master era un duello filosofico, se Licorice Pizza era una lettera d’amore adolescenziale, qui c’è tutto, tutto insieme: manifesto, farsa, melodramma, satira, epopea familiare, tragedia contemporanea. È l’atto con cui Anderson accetta il caos del presente e lo trasforma in Cinema purissimo. Esattamente quel tipo di ossessione che sogniamo di poter chiamare “film dell’anno”. O forse del decennio.
Benedetta Bragadini, RollingStone

16 dicembre 2025
Duse è un’opera libera e incantatrice
Dopo la presentazione in concorso all’ultima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, arriva nelle sale Duse di Pietro Marcello, biopic solo apparente. In realtà è un’opera profondamente ispirata sulla vita e la figura di una delle più grandi interpreti del teatro internazionale, Eleonora Duse, quasi una leggenda.
Più esattamente è un’opera libera come lo era l’attrice, sempre inquieta e sempre in viaggio. Un’icona e insieme una fenice, imprendibile, indefinibile eppure perfettamente incarnata da una grandiosa Valeria Bruni Tedeschi, che restituisce una personalità unica, incerta e appassionata, contraddittoria e lineare. E, con lei, è allo specchio un’epoca che sta ancora uscendo da un cataclisma globale, la prima guerra mondiale, e già sta preparando due cataclismi, se non tre, che si saldano in uno soltanto: l’avvento del fascismo e la seconda guerra mondiale, con annesso l’Olocausto.
Il film si svolge infatti “tra il 1917 e il 1923, un periodo di sconvolgimento sociale per l’Italia, che ha coinciso con l’ultima tournée della Duse prima della partenza per gli Stati Uniti, dove morì nel 1924, a Pittsburgh”. Il film coglie l’attrice nel suo finire che in verità è qui un nuovo inizio, e per questo inizia con due finali e poi con una sorta di resurrezione.
Ne nasce un capolavoro quasi assoluto, un film da vedere e rivedere più volte e che a ogni visione acquista più senso, bellezza e soprattutto forza incantatrice poiché si muove dall’inizio alla fine su un delicato, sottilissimo crinale. Anzi, in tutto e per tutto Duse è sul crinale.
Duse racconta cose dure o crudeli con grande dolcezza, una costante nel cinema di Pietro Marcello. Un cinema come sempre piacevolmente ondulatorio come una ninna nanna incantatrice, ma pervaso dai movimenti sussultori della Storia del novecento, che forgiano e più spesso deformano, devastano, come i peggiori terremoti, le tante storie umane degli umili, degli esseri umani qualsiasi. La loro potenziale felicità. Qui più che mai.
Come ha dichiarato il direttore della Mostra Alberto Barbera, “la reinvenzione scenica del passato e dei suoi protagonisti (Duse, Mussolini, D’Annunzio) si specchia nell’utilizzo di autentici materiali d’archivio – cosa abituale nel regista – qui sfruttati in modo straordinario, con il lungo viaggio della salma del milite ignoto che attraversa l’Italia dalle Alpi al Vittoriale”.
Questo l’altro vero protagonista del film: l’umile, il giovane mandato al macello, che torna mutilato, sfigurato o che non torna più. Il milite ignoto, che domina il Vittoriano di Roma, nasce in questo momento storico e in un certo senso nasce in questo film, poiché la storia qui narrata è fatta letteralmente con il tessuto della Storia, italiana in particolare ma non solo. Lo vediamo apparire lentamente ma in maniera continuata fino a quando nella parte finale si palesa: eppure è lui il fantasma che il film intende rendere visibile, che desidera incarnare senza esibirlo, senza didascalismo. E tuttavia quando giunge al Vittoriano pare quasi una rivelazione.
È un film nel film che conferisce all’opera, e in un certo senso a quella della Duse, tutto il suo senso profondo. Piccolissimo film nel grande film, è metafora di tutti noi che se andassimo in guerra non saremmo altro che piccoli insetti presi nell’ingranaggio della grande storia, delle sue manipolazioni continue, delle sue retoriche eterne.
È lui, l’anonimo soldato triturato dalla prima grande carneficina mondiale che in questa interpretazione cinematografica della Duse – finalmente il cinema non documentario se ne interessa – scatena in lei il progressivo desiderio di sovvertire i canoni obsoleti della sua arte, il teatro. Per lei, sia chiaro, arte somma, per restare nel linguaggio del film. Prima lento – facendo spettacoli ai soldati reduci dal fronte come vediamo all’inizio – ma che via via si fa sempre più forte, inarrestabile. L’agente scatenante di tutto è il soldato rimasto invisibile, ignoto appunto. E che tale resterà per sempre.
Il film così facendo ci parla dell’oggi, in maniera prepotente. La guerra come cosa normale e come retorica normale benché falsa e abusata. La guerra perpetua e infinita perché fa comodo a tutti, o anche la guerra come stato d’ansia continuo, come (pseudo)moto perpetuo della civiltà umana, proprio come la crisi continua. Proprio quando con Donald Trump il turbocapitalismo, già dissennato, sembra farsi superturbocapitalismo, senza nemmeno più qualche residuo di mediazione democratica (e razionale).
Torna allora in mente il brevissimo ma folgorante apologo scritto nel 1946 da Ennio Flaiano, La guerra spiegata ai poveri. Pensato per il teatro, è un dialogo volto a ingannare il Giovane che non capisce la guerra ma che alla fine, faticosamente convinto, ci andrà. Giocato tutto con toni oscillanti tra il surreale e l’assurdo, il Presidente, il Generale, il Perito religioso, la Signora, l’Usciere, il Ministro della superproduzione, Ninì, l’amichetta del Presidente, conversando rivelano secoli di retropensiero e strategia del potere, semplici, ma eterni e basilari, come questo, espresso dal Presidente: “Il dado è tratto. Dichiarata questa guerra, non abbiamo adesso che uno scopo: vincerla o, perlomeno, continuarla”.
Duse è un film che dà nuova consistenza al cinema del passato, che lo rievoca e mai lo cita: dal fondale con paesaggio di una scenografia teatrale si passa a un paesaggio che seppur reale ha un evidente richiamo pittorico e al cinema del passato recente: a Tarkovsky in particolare e forse anche alla gravità di certo Bergman a colori e autunnale o ancora a quello simbolista in bianco e nero degli inizi (Il settimo sigillo, con le sue figure ieratiche in nero e teatrali); e poco prima si pensa ancora soprattutto a Tarkovsky mentre, proprio all’inizio, nella pianura in cui sono radunati i soldati reduci dalla guerra, si pensa alla pittura di un macchiaiolo come Fattori.
Ma alcuni dettagli, alcune macchie bluastre nell’erba e il fondo delle montagne annunciano sia i fondali dipinti che seguiranno sia il blu – un blu sempre sul crinale con il turchese – poi dominante: colore dell’etereo, del romantico, della raffinatezza e di Venezia, città del sogno dove all’orizzonte il colore del mare si confonde con quello del cielo. Città utero che a Duse darà tanto e viceversa.
E poi ancora con un paesaggio veloce colto dal finestrino del treno, denso e coloratissimo, magmatico, di un verde intenso, quasi psichedelico: questo frammento, un frammento di felicità – la più semplice quindi la più intensa, come quella di un bambino – è quello che la Duse vede dal finestrino e cerca di immortalare, nella sua fugacità, con la sua piccolissima cinepresa a manovella, effimera e volatile come un film muto e in bianco e nero. Il viaggio continuo che riassume l’essenza della vita dell’attrice, la vita che scorre o che (s)fugge. O come il flusso di un film, di questo film sul teatro ma non teatrale: piuttosto una contrapposizione affettuosa tra cinema e teatro: Duse è girato in maniera ravvicinata e continuata sui volti ed è spesso sussurrato; il teatro è giocato sui corpi e in genere la recitazione è ben scandita, talvolta altisonante.
Ma nel film su Eleonora Duse si parla anche tanto di arte, di teatro. Tuttavia non esattamente in maniera univoca e lineare. Appassionata nel difendere l’arte e gli amici ma incapace di essere madre – foss’anche in maniera semplice – si farà usare da Mussolini, che assicurerà una pensione all’attrice sommersa dai debiti, nel suo sogno fanciullesco di onorare l’Arte. Eleonora Duse è personaggio contraddittorio. Ma anche impetuoso e commovente come una Giovanna d’Arco dell’arte, capitana di una nave della bellezza in un mare dominato da uomini sparvieri.
Ma qui, a ben vedere, c’è un lavoro sulla recitazione spesso sopra le righe – in particolare nel personaggio di Zacconi, simbolo di un teatro tronfio e altisonante, dove le maiuscole abbondano, che Duse uccide progressivamente anche sotto la spinta di Sarah Bernhardt, sua concorrente diretta: straordinaria la sequenza in cui Duse si confronta con la giovane attrice della pièce di Ibsen, La donna del mare (messa in scena il 5 maggio 1921 al teatro Balbo di Torino): si oscilla continuamente tra registri sottilissimi: il grave, il comico, il melodramma e il farsesco si sovrappongono e si confondono.
Così come la ricerca di vita assoluta sempre e comunque si confonde con l’oblio, desiderato e temuto al contempo, la musica di Beethoven e Vivaldi si confonde con quella elettronica di Marco Messina, appositamente concepita, e il Rondò Veneziano. Una costante del cinema di Marcello è la ricerca, dietro le apparenze, dell’omogeneità nell’eterogeneità, negli opposti, al contrario delle ideologie oggi imperanti. Tra cui anche quelle di sinistra, che vogliono narrazioni un po’ troppo prive dell’ambiguità del mondo reale.
Inoltre, se si parla dell’umile e del milite invisibile, il film narra un personaggio della modernità che è per metà invisibile: niente tracce sonore, un solo film muto con lei protagonista, Cenere, di cui sussistono poche foto e poche lettere. Come incarnare allora la “Divina Eleonora Duse”, “L’araba fenice che ha illuminato La Fenice”, “La matrigna del Teatro del soldato” che ha rivoluzionato completamente l’arte recitativa e che nelle tournée in Europa recitava in italiano, un personaggio che fu vero mito e che ebbe tra i suoi grandi amori perfino “il Vate” Gabriele D’Annunzio (che gli sopravvivrà ma che resterà legato a lei in maniera ombelicale)?
Pietro Marcello lo fa con il film di una biografia incerta al fine di rappresentare un’anima incerta ma allo stesso tempo del tutto certa nella ricerca incontenibile di un assoluto; ricerca fatta attraversando l’arte in tutte le sue sfumature e possibilità e attraversando l’era incerta in cui ha vissuto.
Soprattutto quando alla fine della sua vita si annunciava una seconda, doppia catastrofe: l’avvento del fascismo e un secondo conflitto mondiale. Un’era incerta, tempi incerti dai cattivi, funesti presagi. Proprio come oggi dove siamo tutti – di nuovo – sul crinale.
Francesco Boille, Internazionale

16 dicembre 2025
Arnaud Desplechin celebra il suo amore per il cinema con stile e trasmette il suo entusiasmo allo spettatore
L'intera opera di Arnaud Desplechin è ricca di riferimenti autobiografici. Basti pensare a Paul Dedalus, l'alter ego che compare in molti dei suoi film attraverso i quali offre autoritratti intimi e profondi, o al meraviglioso Roubaix, una luce, un sentito omaggio alla sua maltrattata città natale. Ma è forse Spectateurs!, proiettato nella sezione Zabaltegi-Tabakalera del 72mo Festival di San Sebastian dopo il passaggio nelle proiezioni speciali di Cannes, l'opera in cui il cineasta francese si mette a nudo in modo più diretto. Bastano pochi minuti per capire che Desplechin è ossessionato dal cinema, una fonte di energia indispensabile alla sua vita quasi quanto l'ossigeno. E in questo film prende per mano gli spettatori, li porta in viaggio con lui attraverso i suoi ricordi cinematografici e dà loro un posto centrale affinché, insieme, cerchino di svelare il mistero di quest'arte che continua ad affascinare milioni di persone in tutto il mondo.
Il film è un collage giocoso in cui i generi si intrecciano. Ci sono parti prettamente saggistiche, in cui vengono proposte interessanti riflessioni sull'origine del cinema, sul suo rapporto con la pittura e in cui personaggi come i fratelli Lumière, Eadweard Muybridge o Thomas Edison vengono portati al presente per aiutarci a comprendere la genesi di questa disciplina artistica. Ci sono momenti di riflessione davvero stimolanti, come la conversazione tra alcuni giovani studenti e un esperto di teoria cinematografica in cui si parla di come il film, oltre a catturare la realtà, sia in grado di darle un nuovo significato una volta proiettato agli spettatori, che instaurano un dialogo tra la realtà filmata e la propria, creando una nuova dimensione della realtà.
Bellissime anche le parti del film in cui Desplechin rende omaggio ad altri professionisti del cinema che sono stati fondamentali per la sua crescita come regista. È commovente il modo in cui il regista racconta il suo rapporto con il monumentale Shoah di Claude Lanzmann. Lo shock di scoprirlo da giovane, il modo in cui gli ha rivelato l'immenso potere del cinema di testimoniare l'orrore senza bisogno di immagini esplicite, e il successivo legame con il regista, che è diventato una figura fondamentale nella sua vita professionale e personale. Bellissimo anche l'omaggio alla compianta attrice nativa americana Misty Upham, protagonista del fantastico Frozen River e con cui il francese ha lavorato in Jimmy P. Tutto questo senza dimenticare le parti autobiografiche romanzate, in cui ritroviamo Paul Dedalus (interpretato nelle sue diverse età da Louis Birman, Milo Machado-Graner e Sam Chemoul) e in cui scopriamo passaggi fondamentali della vita di Desplechin in cui il cinema è protagonista tanto quanto lui stesso.
Spectateurs! è, in sintesi, un commovente omaggio al cinema, al suo potere di trasformazione e ai misteri che questo potere comporta. Il tutto firmato da un regista eccezionale, la cui passione per ciò che fa trabocca dallo stretto alone di luce che si trasforma in immagini magiche una volta entrato in contatto con lo schermo.
Cristóbal Soage, Cineuropa