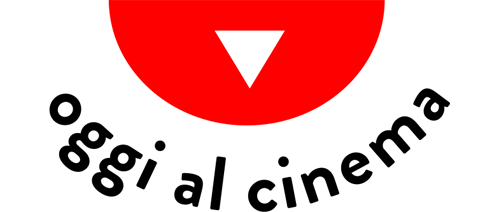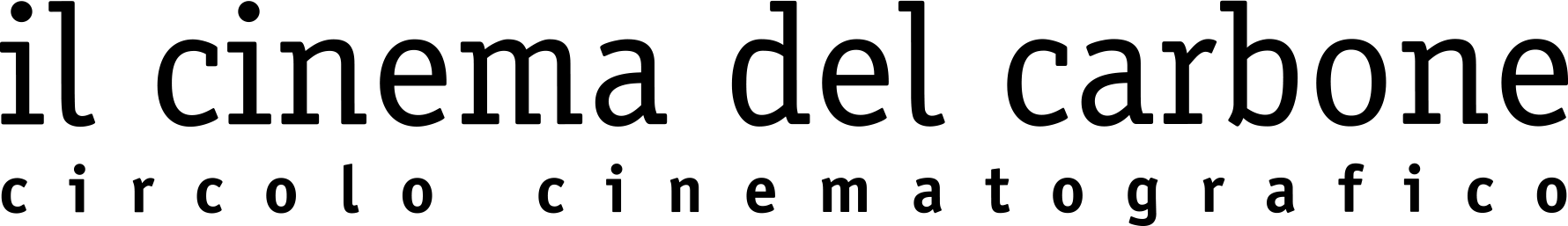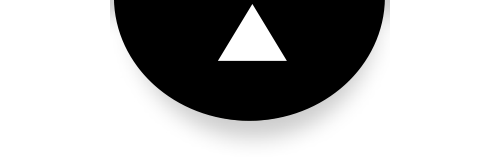19 gennaio 2026
Sorry, Baby: il ritratto dell’essere donna che il cinema aspettava
Ci sono film che ti introducono alla storia, che ti spiegano cosa stai per vedere. E poi ci sono film che ti chiedono una cosa molto più difficile: fiducia.
Sorry, Baby non ti dice tutto subito. Non ti prende per mano. Entra piano e ti chiede di restare anche quando non capisci ancora perché qualcosa fa così male. È un film che si concede il tempo dell’attesa, del silenzio, della fatica. E proprio per questo, quando finalmente ti rendi conto di cosa stai guardando, è già troppo tardi per restarne fuori.
Scritto, diretto e interpretato da Eva Victor, Sorry, Baby arriva al cinema con I Wonder Pictures e si impone come uno degli esordi più delicati e consapevoli degli ultimi anni. Un film che rifiuta l’urgenza di spiegare, di mostrare, di chiarire subito. E che proprio in questa sottrazione trova la sua forza più profonda.
La storia segue Agnes, giovane professoressa di letteratura, attraverso frammenti di quotidianità: lezioni, amicizie, incontri, piccoli gesti che sembrano normali e che invece portano addosso un peso invisibile. All’inizio non sai davvero cosa le sia successo. Lo intuisci. Lo senti. Ma il film non te lo consegna. Lo lascia emergere con fatica, più avanti, senza mai trasformarlo nel centro spettacolare del racconto.
La natura della ferita – una violenza – viene compresa solo dopo, con estrema cautela. Sorry, Baby non ci fa mai entrare davvero “dentro” quell’evento. E non per mancanza di coraggio, ma per una scelta precisa, quasi etica: non raccontare ciò che è accaduto, ma ciò che resta. Il modo in cui il dolore si deposita nel corpo, nella mente, nelle relazioni. Il modo in cui convive con la vita, senza mai coincidere del tutto con essa.
La struttura a capitoli accompagna questo percorso irregolare. Il tempo non è lineare, la guarigione nemmeno. Ci sono momenti di apparente serenità e improvvise ricadute. Risate che arrivano quando non dovrebbero, silenzi che parlano più delle parole. È un racconto che somiglia alla vita vera, non alla sua versione ordinata e rassicurante.
Eva Victor costruisce Agnes lontanissima da qualsiasi idea di “vittima perfetta”. È ironica, spigolosa, impulsiva. A volte è sgradevole, a volte tenerissima. Ride, si arrabbia, pensa cose che non si dicono. Non viene mai addomesticata per risultare più comprensibile allo spettatore. Ed è qui che il film diventa, in modo sorprendentemente potente, un ritratto dell’essere donna – e dell’essere umana: contraddittorio, fragile, dolorosamente vero.
Accanto a lei, Naomi Ackie è straordinaria nel ruolo di Lydie, l’amica che salva non con grandi discorsi ma con la presenza. Quella che resta, che ascolta, che condivide un linguaggio fatto di sguardi, ironia e complicità. Lucas Hedges porta in scena una gentilezza timida, mentre ogni relazione sembra muoversi con lo stesso rispetto che il film chiede a chi guarda.
In questo universo fatto di ferite e resistenze, c’è anche una tenerezza improvvisa e disarmante: quella di un gatto trovato, accolto quasi per caso, che diventa lentamente parte della famiglia. Un dettaglio apparentemente piccolo, ma centrale. Perché racconta la cura che nasce senza proclami, l’amore che arriva quando non lo stai cercando, la possibilità – delicatissima – di legarsi di nuovo a qualcosa di vivo.
È la stessa logica che attraversa tutto il film, anche nel suo uso dell’umorismo. Sorry, Baby ti fa ridere e, subito dopo, senza avvisare, ti stringe lo stomaco. Per me è stato esattamente questo: una carezza capace di far sorridere e, insieme, togliere il fiato. Un umorismo che non serve a sdrammatizzare, ma a sopravvivere. Che smaschera l’ipocrisia delle istituzioni, la freddezza dei sistemi, le solidarietà di facciata. Non consola ma protegge e permette di respirare quando manca l’aria.
Il film si chiude senza spiegare, senza sottolineare, lasciando spazio a un messaggio chiarissimo proprio perché non viene dichiarato: la forza della vicinanza. L’idea che esserci, restare, accompagnarsi possa essere già una forma di salvezza. Per me è davvero importante che esistano film come Sorry, Baby. Film che raccontano l’essere donna – e l’essere umana – senza semplificare, senza violare, senza pretendere di spiegare tutto. Film che si avvicinano con rispetto e che sanno entrare nelle storie senza fare rumore.
Quando esci dalla sala, Sorry, Baby non ti lascia risposte chiare. Ti lascia una sensazione potente addosso. Ed è così che capisci che il cinema, quando è davvero necessario, sa ancora fare questo: entrare piano e restare.
Sara Scarsella, The Hot Corn

07 gennaio 2026
Ultimo schiaffo, una commedia “natalizia” amarognola che si muove nei territori del noir
Si era lasciato il cinema del regista friulano con la mesta dolcezza di Zoran, il mio nipote scemo, e il sogno di improvvida ricchezza dell’alcolizzato Paolo Bressan – che intendeva sfruttare economicamente le eccezionali doti dell’introverso nipote Zoran Spacapan alle freccette – che si riconduceva in direzione di un ritrovato senso dell’esistere, e lo si ritrova adesso tra i monti friulani innevati, nel paesino minerario sperduto e perdente in cui Petra e Jure cercano in ogni modo di sbarcare il lunario: sono sorella e fratello, decisa ad abbandonare quel luogo lei (ma solo insieme all’amato germano) e meno ancorato al reale, più “semplice” lui, che in qualche modo pare una versione aggiornata e corretta di Zoran. L’occasione per racimolare qualche migliaia di euro e cambiare vita – nonostante una madre affetta da demenza senile, che pensa che la figlia sia morta anche quando si trova davanti a lei – potrebbe giungere dalla scomparsa di Marlowe, un cagnolino dal nome altisonante smarrito dalla signora Ines. Questo evento però finisce con lo scoperchiare un nido di vipere, o per meglio dire la mediocrità di un paese molto più sfaldato di quanto si possa pensare.
Nonostante l’ambientazione natalizia Ultimo schiaffo è un’opera che progressivamente abbandona il campo della commedia per scivolare nei territori del noir, sprofondando nell’ombra oscura che tutto attanaglia, a partire da personaggi già sconfitti dalla vita che cercando disperatamente, con le unghie e con i denti, una redenzione o una riscossa che non è detto però possa esser loro concessa. È questa amarezza il punto di forza di una scrittura che ogni tanto sul crinale della commedia si affida alla battuta più facile ma che trova riscatto proprio nella convinzione che l’umanità sia da ricercare anche e soprattutto là dove il sole non riscalda con i suoi raggi, come avrebbe cantato Fabrizio De André. Ne viene fuori un lavoro anche livido, ma che ha nella scrittura dei personaggi la chiave di volta per tentare un’ultima risalita, un ultimo schiaffo in faccia a una vita insolente, barbarica, in fin dei conti profondamente ingiusta. Il cuore pulsante della vicenda sono ovviamente Petra e Jure, e le interpretazioni sorprendenti di Adalgisa Manfrida e Massimiliano Motta aiutano lo spettatore ad accorarsi a questa storia che sembra trovare uno sposalizio ideale tra i derelitti di Aki Kaurismäki e il grottesco di Teemu Nikki: si resta dunque in territori nordici, come dopotutto l’ambientazione suggerisce, con la neve candida che può facilmente macchiarsi di sangue e Babbo Natale che non è esattamente il portatore di doni. Il calore non lo si può qui trovare sotto il vischio o davanti al fuoco di un camino che non c’è – i due protagonisti vivono in una roulotte e faticano a mettere insieme il pranzo con la cena –, ma solo in questi esseri umani che si dibattono per ottenere quella dignità che non è stata loro concessa. Oleotto e il suo team di sceneggiatori (Pier Paolo Piciarelli e Salvatore De Mola) riescono a muoversi con una certa leggerezza tra i generi, e così Ultimo schiaffo riesce nel suo intento, quello di un cinema medio che sappia ancora raccontare l’umano senza per questo affidarsi alla più frusta retorica, e senza mai dimenticare per strada l’aggettivo popolare.
Raffaele Meale, Quinlan

07 gennaio 2026
La villa portoghese: un piacevole racconto morale sugli imprevisti della vita
Avelina Prat, originaria di Valencia, ha lasciato anni fa l'architettura per il cinema, e la possibilità di cambiare il proprio destino, per ragioni che possono venire dall'esterno o dall'interno, è al centro del suo secondo film, La villa portoghese. Al centro del suo film c'è anche l'importanza di trovare un luogo speciale, da poter chiamare casa (l'architettura ha evidentemente piantato dei semi, che continuano a fruttare su un altro terreno).
Per la moglie di Fernando, così come per il vero Manuel, un posto vale un altro: lo sradicamento è diventato un modo di vivere, dettato da un trauma o percepito come sinonimo di libertà. Non è così per Fernando, magnificamente interpretato da Manolo Solo, il quale dovrà fare, però, un lungo giro per arrivare alla meta, e accettare che il proprio posto possa trovarsi molto lontano rispetto a quanto ha sempre creduto. Quando spiega alla sua classe, all'inizio del film, che il modo migliore per conoscere il mondo è disegnarlo (di nuovo, riga, matita e squadre: gli strumenti dell'architettura) e una studentessa gli chiede se non sia meglio invece percorrerlo realmente, viaggiando fisicamente attraverso le terra che sta illustrando sulla cartina, lui non le dà ascolto, ma è esattamente ciò che gli capiterà di esperire da lì a poco e che gli insegnerà la frequentazione dell'enigmatica Amalia interpretata da Maria de Medeiros.
Prat non teme di puntellare questo racconto realistico di colpi di scena incredibili, che servono il tema della morte apparente e della rinascita, così come fa il lavoro di giardinaggio che Manuel/Fernando impara a svolgere; ma gli avvenimenti inverosimili servono anche l'idea che la vita possa sorprendere continuamente, alternando dramma e commedia sentimentale, e rivelandosi così più cinematografica che mai. Un cinema umano e umanista, dunque, quello di Prat, che ragiona attorno al concetto di famiglia acquisita in termini non stereotipati e invita a pensare l'esistenza come passibile di una continua riscrittura.
Marianna Cappi, Mymovies

16 dicembre 2025
Una battaglia dopo l’altra è il film dell’anno, anzi, forse del decennio
Paul Thomas Anderson firma un’opera incendiaria e irresistibile: tra rivoluzione e melodramma familiare, satira e tragedia, un film che spaventa e diverte, galvanizza e disarma. E trasforma il caos del presente in Cinema puro (feat. DiCaprio, Penn, del Toro e Taylor)
Ci sono tante, troppe cose da dire sul film dell’anno, anzi, probabilmente il film del decennio. Provo ad andare in ordine sparso: uno dei nomi più belli di sempre, Perfidia Beverly Hills (forse nom de guerre, ma certamente memorabile come il personaggio di Teyana Taylor); Leonardo DiCaprio in look total Drugo che urla “¡Viva la Revolución!” con il pugno alzato a Benicio del Toro alias un sensei messicano (!), fixer per quella stessa revolución; un’organizzazione segreta di nazionalisti bianchi che si chiama Christmas Adventurers Club (!); almeno un paio di erezioni a favore di camera di Sean Penn in modalità G.I. Joe alt-right quasi chapliniano; suore fiancheggiatrici dei rivoluzionari che coltivano (e fumano) marijuana; un finale (no spoiler) cla-mo-ro-so à la Punto zero, ma come se fosse stato girato da Antonioni (cit. Variety).
Ok, posso riprendere fiato, che è quello che non ho fatto (sì, è un’iperbole, but still) per tutti i 162 minuti di Una battaglia dopo l’altra. Un’invenzione cinematografica paulthomasandersoniana dopo l’altra, un grido di battaglia (pardon) d’auteur, una chiamata alle armi (“La violenza rivoluzionaria è l’unica via”, dice Perfidia) pacifica (?) capace di usare il Cinema per mettere in scena e far detonare le contraddizioni del nostro tempo. Il punto di partenza è il romanzo Vineland di Thomas Pynchon (e non è il primo adattamento by PTA, vedi Vizio di forma), certo, ma non c’è nessun riferimento storico reaganiano, siamo in un presente sospeso che ricorda in modo angosciantissimo l’America di oggi.
“Make it big, make it bright”, raccomanda Perfidia al compagno di vita e d’armi, Ghetto Pat, aka Rocketman, e cioè DiCaprio (#tuttovero). Specialista in bombe e cotillon, guida insieme a lei i French 75, guerriglieri improvvisati e autoproclamatisi combattenti per la libertà che vogliono sovvertire il regime con azioni casuali. Il loro obiettivo: un centro di detenzione per immigrati a San Diego, sperando che sia il primo boom di una rivoluzione.
E “make it big, make it bright” è quello che fa anche Paul Thomas Anderson in questi primi 10 minuti, che poi diventano 20, 30, 40… insomma, avete capito. Entering il colonnello militare Steven J. Lockjaw di Sean Penn con undercut neo-nazi ed espressione di disgusto perenne, responsabile del centro e caricatura vivente del macho suprematista. Ha un debole per Perfidia, che Anderson scolpisce come ribelle nella ribellione, erede di una lunga stirpe di barricaderi neri, amante, miccia politica, incarnazione di una femminilità bellica e senza compromessi: “La fica è per la guerra, è un’arma”. Una frase che è già slogan, disturbante e profetico, che sintetizza corpo e rivoluzione, sesso e violenza, amore e distruzione. Tra Perfidia, Lockjaw e Pat nasce così un triangolo amoroso tra fazioni politiche che più opposte, e più inquietantemente e pericolosamente intrecciate, non potrebbero essere: “Le rivoluzioni iniziano sempre per combattere dei demoni, poi succede che quei demoni combattano loro stessi”, altra cit., altra profezia. Intanto quella stessa rivoluzione donchisciottesca non russa, e continua a colpire tra attentati e rapine in banca: PTA li segue senza giudizio, in un ritmo che cresce fino all’inevitabile esplosione. Ok, è il momento di fare tutti quanti un bel respiro.
E quando pensi che la traiettoria sia segnata, Anderson rimescola le carte e porta la storia altrove. All’improvviso il film diventa anche un dramma familiare, tenero e devastante: perché il politico è personale, e il personale non è mai stato così politico. DiCaprio è vulnerabilità nel caos, scalda la parte forse più cerebrale del film, pare quasi liberato da una comicità e uno sconvolgimento che lo umanizzano. È l’omaggio del regista (che ha ben tre figlie, e si sente) a un padre imperfetto che cerca disperatamente di non trasmettere il fallimento a chi viene dopo di lui. Il momento in cui non ricorda la risposta in codice alla domanda “Che ore sono?” (nessuno spoiler, è nel trailer) per comunicare con gli amici ribelli è già cult: un dettaglio comico che diventa critica feroce al linguaggio sterile di un certo liberalismo incapace di parlare a chi vorrebbe difendere.
Dall’altra parte della barricata, Sean Penn incarna una satira agghiacciante e insieme irresistibile dell’action man razzista e misogino: un gioco di rimandi e deformazioni che tocca l’apice della sua carriera e lo fa entrare per direttissima nella galleria dei personaggi indimenticabili di Paul Thomas Anderson. Il suo colonnello Lockjaw è al tempo stesso parodia e minaccia, clown tragico e mostro politico. E poi Benicio (basta il nome), che Anderson immagina come un santo protettore di migranti, braccio armato e spirituale di una rivoluzione che forse non è mai davvero cominciata. L’uomo che conosce il confine con il Messico e i suoi segreti, che ha visto troppa violenza per credere ancora nella purezza di una causa. Del Toro si muove lento, parla poco, osserva tutto: un personaggio da antologia, costruito più sui silenzi che sulle parole.
E proprio dai silenzi parte Jonny Greenwood, per riempirli o spezzarli: archi che graffiano, chitarre che esplodono, vuoti improvvisi che diventano assordanti, o una singola, insistente nota di pianoforte che restituisce tutta la tensione, narrativa e umana. Greenwood non accompagna: scrive a sua volta battaglie interiori, un controcanto che amplifica ogni gesto, ogni urlo, ogni smorfia dei protagonisti.
Una battaglia dopo l’altra spaventa e diverte, galvanizza e disarma. Ha fatto impazzire Spielberg, che l’ha visto tre volte e l’ha paragonato al Dottor Stranamore: “Arrivi a un punto dove vuoi ridere, perché se non ti metti a ridere inizi ad urlare”, ha detto. “È tutto troppo reale”. Troppo vicino, troppo adesso. È un nuovo classico: un film d’Autore che diventa un blockbuster ineluttabile. È il lavoro di un Cineasta al massimo della forma, capace di raccogliere il delirio dell’attualità e di farne – lo dico? Sì, lo dico – un capolavoro contemporaneo.
Politicamente affilato senza mai essere moralista, Anderson costruisce un racconto ricco di azione che una volta ingranata la marcia non si ferma più, e che sa alternare l’epica incendiaria a momenti di comicità folgorante. È un film che ha la forza delle proprie convinzioni: ride, sì, ma ride con i denti stretti, perché dietro la risata c’è la vertigine dell’analisi spietata sugli Stati Uniti che non sono mai stati tanto sull’orlo del collasso. Eppure PTA non cede mai alla tentazione del pamphlet: i suoi personaggi restano al centro, con le loro fragilità, i loro fallimenti, le loro ombre. La rivoluzione resta sempre e comunque un fatto umano, prima che politico.
E proprio per questo Una battaglia dopo l’altra è forse il film più radicale della sua filmografia: se Il petroliere era una tragedia americana, se The Master era un duello filosofico, se Licorice Pizza era una lettera d’amore adolescenziale, qui c’è tutto, tutto insieme: manifesto, farsa, melodramma, satira, epopea familiare, tragedia contemporanea. È l’atto con cui Anderson accetta il caos del presente e lo trasforma in Cinema purissimo. Esattamente quel tipo di ossessione che sogniamo di poter chiamare “film dell’anno”. O forse del decennio.
Benedetta Bragadini, RollingStone

16 dicembre 2025
Duse è un’opera libera e incantatrice
Dopo la presentazione in concorso all’ultima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, arriva nelle sale Duse di Pietro Marcello, biopic solo apparente. In realtà è un’opera profondamente ispirata sulla vita e la figura di una delle più grandi interpreti del teatro internazionale, Eleonora Duse, quasi una leggenda.
Più esattamente è un’opera libera come lo era l’attrice, sempre inquieta e sempre in viaggio. Un’icona e insieme una fenice, imprendibile, indefinibile eppure perfettamente incarnata da una grandiosa Valeria Bruni Tedeschi, che restituisce una personalità unica, incerta e appassionata, contraddittoria e lineare. E, con lei, è allo specchio un’epoca che sta ancora uscendo da un cataclisma globale, la prima guerra mondiale, e già sta preparando due cataclismi, se non tre, che si saldano in uno soltanto: l’avvento del fascismo e la seconda guerra mondiale, con annesso l’Olocausto.
Il film si svolge infatti “tra il 1917 e il 1923, un periodo di sconvolgimento sociale per l’Italia, che ha coinciso con l’ultima tournée della Duse prima della partenza per gli Stati Uniti, dove morì nel 1924, a Pittsburgh”. Il film coglie l’attrice nel suo finire che in verità è qui un nuovo inizio, e per questo inizia con due finali e poi con una sorta di resurrezione.
Ne nasce un capolavoro quasi assoluto, un film da vedere e rivedere più volte e che a ogni visione acquista più senso, bellezza e soprattutto forza incantatrice poiché si muove dall’inizio alla fine su un delicato, sottilissimo crinale. Anzi, in tutto e per tutto Duse è sul crinale.
Duse racconta cose dure o crudeli con grande dolcezza, una costante nel cinema di Pietro Marcello. Un cinema come sempre piacevolmente ondulatorio come una ninna nanna incantatrice, ma pervaso dai movimenti sussultori della Storia del novecento, che forgiano e più spesso deformano, devastano, come i peggiori terremoti, le tante storie umane degli umili, degli esseri umani qualsiasi. La loro potenziale felicità. Qui più che mai.
Come ha dichiarato il direttore della Mostra Alberto Barbera, “la reinvenzione scenica del passato e dei suoi protagonisti (Duse, Mussolini, D’Annunzio) si specchia nell’utilizzo di autentici materiali d’archivio – cosa abituale nel regista – qui sfruttati in modo straordinario, con il lungo viaggio della salma del milite ignoto che attraversa l’Italia dalle Alpi al Vittoriale”.
Questo l’altro vero protagonista del film: l’umile, il giovane mandato al macello, che torna mutilato, sfigurato o che non torna più. Il milite ignoto, che domina il Vittoriano di Roma, nasce in questo momento storico e in un certo senso nasce in questo film, poiché la storia qui narrata è fatta letteralmente con il tessuto della Storia, italiana in particolare ma non solo. Lo vediamo apparire lentamente ma in maniera continuata fino a quando nella parte finale si palesa: eppure è lui il fantasma che il film intende rendere visibile, che desidera incarnare senza esibirlo, senza didascalismo. E tuttavia quando giunge al Vittoriano pare quasi una rivelazione.
È un film nel film che conferisce all’opera, e in un certo senso a quella della Duse, tutto il suo senso profondo. Piccolissimo film nel grande film, è metafora di tutti noi che se andassimo in guerra non saremmo altro che piccoli insetti presi nell’ingranaggio della grande storia, delle sue manipolazioni continue, delle sue retoriche eterne.
È lui, l’anonimo soldato triturato dalla prima grande carneficina mondiale che in questa interpretazione cinematografica della Duse – finalmente il cinema non documentario se ne interessa – scatena in lei il progressivo desiderio di sovvertire i canoni obsoleti della sua arte, il teatro. Per lei, sia chiaro, arte somma, per restare nel linguaggio del film. Prima lento – facendo spettacoli ai soldati reduci dal fronte come vediamo all’inizio – ma che via via si fa sempre più forte, inarrestabile. L’agente scatenante di tutto è il soldato rimasto invisibile, ignoto appunto. E che tale resterà per sempre.
Il film così facendo ci parla dell’oggi, in maniera prepotente. La guerra come cosa normale e come retorica normale benché falsa e abusata. La guerra perpetua e infinita perché fa comodo a tutti, o anche la guerra come stato d’ansia continuo, come (pseudo)moto perpetuo della civiltà umana, proprio come la crisi continua. Proprio quando con Donald Trump il turbocapitalismo, già dissennato, sembra farsi superturbocapitalismo, senza nemmeno più qualche residuo di mediazione democratica (e razionale).
Torna allora in mente il brevissimo ma folgorante apologo scritto nel 1946 da Ennio Flaiano, La guerra spiegata ai poveri. Pensato per il teatro, è un dialogo volto a ingannare il Giovane che non capisce la guerra ma che alla fine, faticosamente convinto, ci andrà. Giocato tutto con toni oscillanti tra il surreale e l’assurdo, il Presidente, il Generale, il Perito religioso, la Signora, l’Usciere, il Ministro della superproduzione, Ninì, l’amichetta del Presidente, conversando rivelano secoli di retropensiero e strategia del potere, semplici, ma eterni e basilari, come questo, espresso dal Presidente: “Il dado è tratto. Dichiarata questa guerra, non abbiamo adesso che uno scopo: vincerla o, perlomeno, continuarla”.
Duse è un film che dà nuova consistenza al cinema del passato, che lo rievoca e mai lo cita: dal fondale con paesaggio di una scenografia teatrale si passa a un paesaggio che seppur reale ha un evidente richiamo pittorico e al cinema del passato recente: a Tarkovsky in particolare e forse anche alla gravità di certo Bergman a colori e autunnale o ancora a quello simbolista in bianco e nero degli inizi (Il settimo sigillo, con le sue figure ieratiche in nero e teatrali); e poco prima si pensa ancora soprattutto a Tarkovsky mentre, proprio all’inizio, nella pianura in cui sono radunati i soldati reduci dalla guerra, si pensa alla pittura di un macchiaiolo come Fattori.
Ma alcuni dettagli, alcune macchie bluastre nell’erba e il fondo delle montagne annunciano sia i fondali dipinti che seguiranno sia il blu – un blu sempre sul crinale con il turchese – poi dominante: colore dell’etereo, del romantico, della raffinatezza e di Venezia, città del sogno dove all’orizzonte il colore del mare si confonde con quello del cielo. Città utero che a Duse darà tanto e viceversa.
E poi ancora con un paesaggio veloce colto dal finestrino del treno, denso e coloratissimo, magmatico, di un verde intenso, quasi psichedelico: questo frammento, un frammento di felicità – la più semplice quindi la più intensa, come quella di un bambino – è quello che la Duse vede dal finestrino e cerca di immortalare, nella sua fugacità, con la sua piccolissima cinepresa a manovella, effimera e volatile come un film muto e in bianco e nero. Il viaggio continuo che riassume l’essenza della vita dell’attrice, la vita che scorre o che (s)fugge. O come il flusso di un film, di questo film sul teatro ma non teatrale: piuttosto una contrapposizione affettuosa tra cinema e teatro: Duse è girato in maniera ravvicinata e continuata sui volti ed è spesso sussurrato; il teatro è giocato sui corpi e in genere la recitazione è ben scandita, talvolta altisonante.
Ma nel film su Eleonora Duse si parla anche tanto di arte, di teatro. Tuttavia non esattamente in maniera univoca e lineare. Appassionata nel difendere l’arte e gli amici ma incapace di essere madre – foss’anche in maniera semplice – si farà usare da Mussolini, che assicurerà una pensione all’attrice sommersa dai debiti, nel suo sogno fanciullesco di onorare l’Arte. Eleonora Duse è personaggio contraddittorio. Ma anche impetuoso e commovente come una Giovanna d’Arco dell’arte, capitana di una nave della bellezza in un mare dominato da uomini sparvieri.
Ma qui, a ben vedere, c’è un lavoro sulla recitazione spesso sopra le righe – in particolare nel personaggio di Zacconi, simbolo di un teatro tronfio e altisonante, dove le maiuscole abbondano, che Duse uccide progressivamente anche sotto la spinta di Sarah Bernhardt, sua concorrente diretta: straordinaria la sequenza in cui Duse si confronta con la giovane attrice della pièce di Ibsen, La donna del mare (messa in scena il 5 maggio 1921 al teatro Balbo di Torino): si oscilla continuamente tra registri sottilissimi: il grave, il comico, il melodramma e il farsesco si sovrappongono e si confondono.
Così come la ricerca di vita assoluta sempre e comunque si confonde con l’oblio, desiderato e temuto al contempo, la musica di Beethoven e Vivaldi si confonde con quella elettronica di Marco Messina, appositamente concepita, e il Rondò Veneziano. Una costante del cinema di Marcello è la ricerca, dietro le apparenze, dell’omogeneità nell’eterogeneità, negli opposti, al contrario delle ideologie oggi imperanti. Tra cui anche quelle di sinistra, che vogliono narrazioni un po’ troppo prive dell’ambiguità del mondo reale.
Inoltre, se si parla dell’umile e del milite invisibile, il film narra un personaggio della modernità che è per metà invisibile: niente tracce sonore, un solo film muto con lei protagonista, Cenere, di cui sussistono poche foto e poche lettere. Come incarnare allora la “Divina Eleonora Duse”, “L’araba fenice che ha illuminato La Fenice”, “La matrigna del Teatro del soldato” che ha rivoluzionato completamente l’arte recitativa e che nelle tournée in Europa recitava in italiano, un personaggio che fu vero mito e che ebbe tra i suoi grandi amori perfino “il Vate” Gabriele D’Annunzio (che gli sopravvivrà ma che resterà legato a lei in maniera ombelicale)?
Pietro Marcello lo fa con il film di una biografia incerta al fine di rappresentare un’anima incerta ma allo stesso tempo del tutto certa nella ricerca incontenibile di un assoluto; ricerca fatta attraversando l’arte in tutte le sue sfumature e possibilità e attraversando l’era incerta in cui ha vissuto.
Soprattutto quando alla fine della sua vita si annunciava una seconda, doppia catastrofe: l’avvento del fascismo e un secondo conflitto mondiale. Un’era incerta, tempi incerti dai cattivi, funesti presagi. Proprio come oggi dove siamo tutti – di nuovo – sul crinale.
Francesco Boille, Internazionale

16 dicembre 2025
Arnaud Desplechin celebra il suo amore per il cinema con stile e trasmette il suo entusiasmo allo spettatore
L'intera opera di Arnaud Desplechin è ricca di riferimenti autobiografici. Basti pensare a Paul Dedalus, l'alter ego che compare in molti dei suoi film attraverso i quali offre autoritratti intimi e profondi, o al meraviglioso Roubaix, una luce, un sentito omaggio alla sua maltrattata città natale. Ma è forse Spectateurs!, proiettato nella sezione Zabaltegi-Tabakalera del 72mo Festival di San Sebastian dopo il passaggio nelle proiezioni speciali di Cannes, l'opera in cui il cineasta francese si mette a nudo in modo più diretto. Bastano pochi minuti per capire che Desplechin è ossessionato dal cinema, una fonte di energia indispensabile alla sua vita quasi quanto l'ossigeno. E in questo film prende per mano gli spettatori, li porta in viaggio con lui attraverso i suoi ricordi cinematografici e dà loro un posto centrale affinché, insieme, cerchino di svelare il mistero di quest'arte che continua ad affascinare milioni di persone in tutto il mondo.
Il film è un collage giocoso in cui i generi si intrecciano. Ci sono parti prettamente saggistiche, in cui vengono proposte interessanti riflessioni sull'origine del cinema, sul suo rapporto con la pittura e in cui personaggi come i fratelli Lumière, Eadweard Muybridge o Thomas Edison vengono portati al presente per aiutarci a comprendere la genesi di questa disciplina artistica. Ci sono momenti di riflessione davvero stimolanti, come la conversazione tra alcuni giovani studenti e un esperto di teoria cinematografica in cui si parla di come il film, oltre a catturare la realtà, sia in grado di darle un nuovo significato una volta proiettato agli spettatori, che instaurano un dialogo tra la realtà filmata e la propria, creando una nuova dimensione della realtà.
Bellissime anche le parti del film in cui Desplechin rende omaggio ad altri professionisti del cinema che sono stati fondamentali per la sua crescita come regista. È commovente il modo in cui il regista racconta il suo rapporto con il monumentale Shoah di Claude Lanzmann. Lo shock di scoprirlo da giovane, il modo in cui gli ha rivelato l'immenso potere del cinema di testimoniare l'orrore senza bisogno di immagini esplicite, e il successivo legame con il regista, che è diventato una figura fondamentale nella sua vita professionale e personale. Bellissimo anche l'omaggio alla compianta attrice nativa americana Misty Upham, protagonista del fantastico Frozen River e con cui il francese ha lavorato in Jimmy P. Tutto questo senza dimenticare le parti autobiografiche romanzate, in cui ritroviamo Paul Dedalus (interpretato nelle sue diverse età da Louis Birman, Milo Machado-Graner e Sam Chemoul) e in cui scopriamo passaggi fondamentali della vita di Desplechin in cui il cinema è protagonista tanto quanto lui stesso.
Spectateurs! è, in sintesi, un commovente omaggio al cinema, al suo potere di trasformazione e ai misteri che questo potere comporta. Il tutto firmato da un regista eccezionale, la cui passione per ciò che fa trabocca dallo stretto alone di luce che si trasforma in immagini magiche una volta entrato in contatto con lo schermo.
Cristóbal Soage, Cineuropa

15 dicembre 2025
Vita privata è una sciarada cangiante con Jodie Foster in stato di grazia: irresistibile!
Nasce da un'ossessione molto confessata per il film omonimo di Louis Malle con Marcello Mastroianni e Brigitte Bardot (1962). Ma in realtà, è tutt'altra storia. È nei cinema italiani, grazie a Europictures, Vita privata, ultimo film della regista e sceneggiatrice francese Rebecca Zlotowski. Da vedere, anche solo per la performance perfetta di Jodie Foster. Ma non solo per lei. Non lasciatevi scappare questa commedia nera, tra giallo e thriller psicologico, alla quale partecipano anche Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste e Luana Bajrami. [...]
È un thriller o no, il film di Rebecca Zlotowski? Difficile dirlo. Del thriller ha tutto, dall'inizio alla fine. Ma le sensazioni che lascia sono (anche) altre. La questione semmai è su quale sia l'oggetto - o il soggetto - indagato. Al centro, c'è sicuramente una perfetta Jodie Foster, psichiatra disciplinata improvvisamente persa quando vede messi in crisi i punti fermi della propria vita. Soprattutto professionale. L'equilibrio instabile con il quale combatte la protagonista è lo stesso che la regista le costruisce intorno, con un film dalla struttura narrativa cangiante. Un noir emotivo, a tratti paradossale, quasi umoristico, con parentesi di dramma familiare. Con la scusa di scoprire il "colpevole”, ci interroghiamo sulle nostre vite, sicurezze, verità private.
Non nuova allo studio dell'identità femminile, la Zlotowski si affida - e invita tutti a farlo - al dubbio, all'incertezza, anche costringendo a una curiosa convivenza forzata psicanalisi e ipnosi, sogno e paranoia. Nulla sembra assicurare risposte certe, perché non esiste una sola verità, se non quella alla quale decidiamo di credere. Del resto una psichiatra con così tante paure di non corrispondere alle altrui e proprie aspettative, schiacciata dal peso dei sensi di colpa tanto da piangere ininterrottamente, ricolma di manie di persecuzione e malata di teorie di cospirazioni... è un personaggio gioiello. Jodie Foster è bravissima a trasformarla in una donna vera. Daniel Auteuil, col suo splendido monologo sull'amore, è perfettamente alla sua altezza. Il risultato è una sciarada che gioca con ambiguità e apparenti opposizioni. E si conclude con una grandissima lezione di libertà e rispetto.
Mattia Pasquini , StyleMagazine Corriere

10 dicembre 2025
Gioia mia, lo splendido e accorato racconto della relazione affettiva tra una anziana zia e il nipotino
Hanno circa settant’anni di differenza Aurora Quattrocchi e Marco Fiore, i due splendidi protagonisti di Gioia mia, film con cui esordisce al lungometraggio la quarantaseienne palermitana Margherita Spampinato, che ebbe modo di farsi notare con un paio di corti – Tommasina, del 2008, e Segreti, del 2012 – che ponevano al centro del discorso da un lato la vecchiaia e dall’altro l’infanzia. Questo primo lavoro sulla lunga distanza sembra quindi cercare e trovare il punto d’incontro su due altezze di sguardo solo all’apparenza agli antipodi, e che rappresentano al momento il principale interesse di Spampinato. Marco Fiore interpreta qui Nico un bambino che, inviato in Sicilia dai genitori per passare l’estate da una zia (ovviamente Aurora Quattrocchi) dopo che la sua amatissima tata non ha potuto continuare a stare con lui, si trova a tu per tu con un mondo lontanissimo, fatto di preghiera e giochi a carte, lui che è cresciuto con un cellulare in mano e senza alcun rapporto con il concetto di “religione”. L’idea dei mondi che si scontrano, tra un microcosmo arcaico e la modernità, non è di certo nuova all’interno delle narrazioni cinematografiche contemporanee, eppure durante la visione si ha la netta percezione che Spampinato sia stata in grado di trovare coordinate del tutto personali, distanti anni luce dalla prassi, come se la messa a fuoco di un ambiente “reale” potesse includere al proprio interno riflessi truffautiani, senza però che l’inseguimento dell’istante equivalga alvenir meno di un solido racconto di formazione. Così un’uscita a mare con la zia o giocare per strada a nascondino non sono elementi spuri per trasmettere una veridicità, ma elementi che concorrono a formare la psicologia dei personaggi, ad alimentare una dinamica di formazione che è poi la base portante del discorso.
[...] c’è una dolcezza profonda e insondabile che attraversa le curvature del racconto in Gioia mia, e Spampinato sa trattenerla con una maestria rara per un’esordiente. Lo si avverte ovviamente negli irresistibili battibecchi tra zia e nipote, ma anche in quell’amicizia/innamoramento tra il solingo e anche scontroso Nico e una bambina che vive nello stesso palazzo storico (notevole anche l’interpretazione della piccola Martina Ziami), e che lo convince a entrare di soppiatto in un appartamento abitato dai “fantasmi”. [...]
La linearità del racconto (assai divertente, per di più), che non disdegna l’appoggiarsi ad archetipi narrativi e strutture predette, permette a Spampinato di lavorare sull’immagine, sulla sua stratificazione, sulla rappresentazione come sintesi tra il vero e il credibile, facendo sua di nuovo la lezione di Truffaut che fu però anche di Vittorio De Sica e di chiunque abbia accolto la messa in scena dell’infanzia come momento di confronto con un’epoca – quella appunto dei più piccoli – da tempo “scomparsa”. Se c’è una nostalgia, in Gioia mia, non è per l’amore perduto o per ciò che non si è più, ma per l’immagine perduta, quella di un cinema che non ha bisogno di alcuna adulterazione ma vive e pulsa nel momento stesso in cui si immortala un gesto, un’espressione del viso, un muoversi delle tende. Si respira aria di un cinema d’antan, nell’esordio di Spampinato, che in pochi oggi sembrano avere il coraggio di produrre e maneggiare, immaginario che forse potrà anche tenere a distanza alcuni critici per via della sua (apparente) semplicità. È invece da opere come Gioia mia che la stanca e spesso mediocre produzione italiana dovrebbe trovare la scintilla per rimettersi in gioco, scartando la facile copertina dell’arthouse per tornare a toccare le cose con mano, a materializzare il mistero, a frammentare l’amore e la memoria in un campo controcampo.
Raffaele Meale, Quinlan

03 dicembre 2025
Un caos narrativo irresistibile: Le città di pianura
Le città di pianura non è una commedia in senso tradizionale, ma si ride. Non è il classico film italiano in cui i personaggi si spostano dal nord al sud, ma si viaggia molto. Non è un film d’autore, ma è anche chiaro che c'è un’idea di cosa possa essere un film italiano che non corrisponde a niente di quello che solitamente si vede. Le città di pianura è una piacevole stranezza, il migliore dei film italiani che si sono visti allo scorso festival di Cannes, un film moderatamente fuori dai canoni che fa cinema come pare a lui e racconta qualcosa che evidentemente conosce benissimo: il nord-est italiano come mood e stile di vita.
In realtà la cosa è più vicina a Le città di pianura è Il sorpasso di Dino Risi, solo che è tutto sbagliato, vago, alticcio e disordinato. Di quel film ha l’idea di un personaggio (qui sono due) che ne coinvolge un altro più rigoroso e morigerato in un viaggio a vuoto, senza una vera meta. Un giretto. E nel fare questo gli mostra involontariamente un altro modo di vivere. C’è anche la macchina bella e costosa. Solo che nel fare tutto questo i due Gassman di questo film sono così stonati dal continuo bere di locale in locale, bacaro, pub, bar o ristorante, che non riescono nemmeno veramente a coinvolgere Filippo Scotti (È stata la mano di Dio), studentello innamorato non ricambiato.
Lo spettacolo quindi sono i due protagonisti, Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla (quello del Teatro degli Orrori), che sembrano usciti da un film di Aki Kaurismäki, individui marginali fuori da ogni moda, con la bevuta facile e una visione di mondo loro. [...] La forza di Le città di pianura è che, mentre fa il lavoro tipico del cinema italiano (agitare dei personaggi in primo piano per raccontare lo sfondo), apre continuamente trame nuove e storie che non saranno mai chiuse né andranno da alcuna parte. Sempre più esilaranti. È un caos narrativo bellissimo e mai fastidioso, alimentato dall’alcol non per stordirsi ma per tenere uno stile di vita piacevolmente alterato, leggero e soffice. Il tanto che basta per non tornare mai sobri. Non è difficile riconoscere in questi personaggi la rappresentazione di figure di contorno del nord-est italiano, caratteristi della vita vera che qui sono elevati a protagonisti. Dietro a tutto c’è Francesco Sossai. È al secondo film, ma è come se fosse il primo, tanto poco ha girato in Italia il primo. Lui dirige e scrive con Adriano Candiago, il film con una libertà eccezionale [...] anche perché Sossai ha l’intelligenza di non farci ridere solo di loro, ma farci ridere di loro con loro. Non siamo spettatori che stanno fuori dalla storia, siamo semmai noi i Trintignant coinvolti in questo giretto, contagiati dai protagonisti.
Gabriele Niola, Wired

03 dicembre 2025
Una testimonianza urgente e necessaria: Put Your Soul on Your Hand and Walk
Più si avvicina la morte, più si amplifica il senso di alienazione. E con esso quel pericoloso senso di assuefazione, per noi “spettatori”, di un qualcosa che non può, non deve, essere considerato la normalità.
È forse questo il momento cruciale di Put Your Soul on Your Hand and Walk, il film della regista dissidente iraniana Sepideh Farsi, già ospitato in ACID a Cannes 2025 e in Special Screenings alla XX Festa di Roma, che racconta Gaza attraverso mesi di videochiamate con Fatma Hassouna, giovane scrittrice, fotografa e giornalista palestinese, poi uccisa insieme alla sua famiglia nella notte del 16 aprile 2025, in seguito ad un attacco aereo che ha colpito la sua casa nel quartiere di Al-Tuffah, esattamente un giorno dopo l’ultima conversazione avuta con la Farsi, che la informava del fatto che il film era stato selezionato al Festival di Cannes.
In una delle ultime telefonate Fatma confida a Sepideh questa sensazione depressiva, questo svuotamento che la costringe a non desiderare più nulla, a rimanere ferma ad osservare tutto il dolore che la circonda. E proprio in quel momento è come se venissimo chiamati in causa anche noi, “spettatori” inermi di una tragedia che non può lasciare indifferenti.
“Ogni secondo, quando cammini per strada, metti l'anima in mano e cammina”: così facendo Fatma ha potuto documentare l’orrore quotidiano vissuto dalla sua terra all’indomani del 7 ottobre 2023.
E le sue foto riempiono il silenzio dell’orrore, tra una videochiamata e l’altra: “Quando ho incontrato Fatma Hassona è avvenuto un miracolo. Lei è diventata i miei occhi a Gaza, dove resisteva documentando giorno per giorno la guerra. E io sono diventata un collegamento tra lei e il resto del mondo, dalla sua ‘prigione di Gaza’, come la definiva lei. Abbiamo mantenuto questa linea di comunicazione per quasi un anno. I frammenti di pixel e suoni che ci siamo scambiate sono diventati il film che vedete”, spiega la regista iraniana, capace di instaurare con Fatma un rapporto a distanza che poco a poco si fa sempre più amichevole, intimo, alternando questa linea narrativa – contraddistinta dall’instabilità della connessione – alla nitidezza di un reportage dal campo.
Il sorriso di Fatma, anche quando racconta e mostra i bombardamenti che hanno raso al suolo i palazzi adiacenti, è il simbolo di una resistenza che va oltre il concetto di vita e di morte: “Non ci sconfiggeranno mai”, dice ad un certo punto, nonostante la sistematica distruzione portata avanti da Israele per annientare il suo popolo. Affidandosi poi ad un sogno purtroppo reciso troppo presto: "Spero di vivere la vita che voglio. Devo continuare a documentare, così potrò raccontare ai miei figli quello che ho passato e quello a cui sono sopravvissuta". Non ha avuto il tempo di avere figli, Fatma, ma quello che hanno visto i suoi occhi, e la sua voce (anche attraverso le sue poesie), non moriranno mai. Anche grazie al lavoro di Sepideh Farsi, regista iraniana di stanza parigina che non può far ritorno nel suo paese.
Valerio Sammarco, Cinematografo