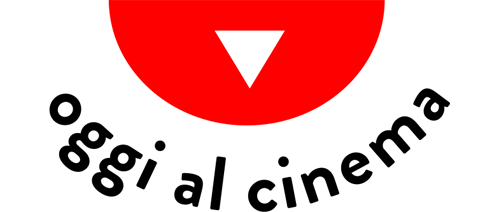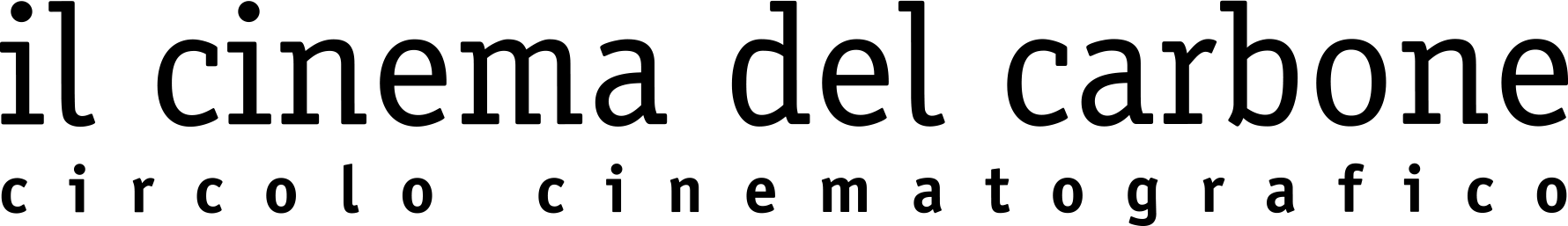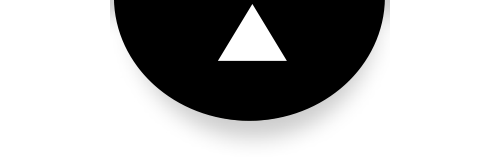Una settimana e un giorno
di Asaph Polonsky — Israele, 2016, 98'
con Uri Gavriel, Tomer Kapon, Sharon Alexander, Shai Avivi, Evgenia Dodina
Quando la settimana ebraica di lutto per il figlio scomparso giunge a termine, Eyal è atteso dalla moglie Vicky che vorrebbe spingerlo a ritornare alla normalità di tutti i giorni. Eyal, invece, stringe amicizia con un giovane vicino di casa scoprendo che esistono ancora ragioni per cui vale la pena vivere.
Probabilmente nessun’altra cultura come quella ebraica ha saputo ironizzare in maniera così profonda e radicale su se stessa, fin quasi all’autolesionismo. Ma del mordace umorismo yiddish, che nasceva proprio dal dolore dell’assenza di una patria e che arrivava a mettere sadomasochisticamente in discussione perfino i dettami religiosi, purtroppo è rimasto poco, confluito in minima parte nella nuova lingua e cultura israeliana e più che altro sopravvissuto nel temperamento di alcuni celebri ‘esuli’ di altre nazionalità, che mai si sono trapiantati nella Terra Promessa: Woody Allen ovviamente, i fratelli Coen o, in letteratura, Philip Roth.
Non si può che accogliere quindi positivamente la scoperta di un regista americano di nascita, ma cresciuto in Israele, come Asaph Polonsky che con il suo esordio Una settimana e un giorno, presentato alla scorsa edizione della Semaine de la Critique e ora in uscita in Italia, riflette proprio intorno a questi temi, partendo dalla tradizione della Shiva (elaborazione di un lutto familiare da osservare in casa per il periodo di una settimana) e mettendola in ridicolo, ma finendovi allo stesso tempo, dolorosamente, per aderirvi.
Il protagonista Eyal, interpretato da Shai Avivi (impressionante per presenza scenica), ha infatti perso un figlio, come veniamo a sapere all’inizio di Una settimana e un giorno: la Shiva però si è appena conclusa e lui non sembra aver voglia di tornare alla vita normale.
Se sua moglie pare accogliere l’evento come un destino cui non ci si può negare, lui al contrario si pone con un netto atteggiamento di rifiuto, tuffandosi però non nella disperazione, quanto – a un livello superficiale – nello sberleffo. Se ne infischia dei vicini che vanno a trovarlo all’ultimo momento, e li umilia; va in ospedale nella stanza dove era ricoverato suo figlio per recuperare un plaid che gli apparteneva e si mette a rovistare tra gli oggetti di un moribondo; litiga e si insulta per futili motivi con un tassista; si fa le canne con il figlio di quegli stessi vicini di casa con cui ha litigato, suggerendo il malefico intento di accaparrarsi la prole altrui e di deviarne l’esistenza.
Attraverso di lui emerge, in sostanza, il ritratto di una comunità che, non sapendo elaborare il lutto e avendo dunque perso il senso ultimo della Shiva, non sa più comportarsi: questa società, quella israeliana per l’appunto, appare ribaltata, ha smarrito le più elementari regole di vita e sbanda ottusamente senza una meta.
Si ritrova nella perdizione ombelicale del protagonista di Una settimana e un giorno lo stesso disfattismo auto-flagellante di Il lamento di Portnoy di Philip Roth, lo stesso umorismo disperatamente volgare sulla morte e sulla religione, lo stesso rifiuto verso regole millenarie.
Ma, progressivamente, nel corso di questa giornata in più rispetto alla Shiva che viene citata nel titolo, Eyal capisce. Continua a immergersi nella demenzialità, ma comincia anche a ritrovare la consapevolezza per andare avanti. Comprende, ad esempio, che non deve comportarsi da figlio del ragazzo disadattato di cui si trova ad essere vicino di casa o che non deve lasciarsi guidare dalla bambina giudiziosa che ha la madre malata, ma che spetta a lui assumersi un ruolo di responsabilità. Anche se, in fin dei conti, tutto è insensato.
Eyal sa già che la vita non ha senso di fronte alla morte, ma impara ad accettarla lo stesso nel momento in cui si trova ad assistere a un’altra cerimonia funebre, quella di un uomo che ha perso la sorella. Questi recita un de profundis commovente, giusto, posato, in linea con la tradizione e, ad un certo punto, cominciamo a vederlo svolgere, in flashback o forse come frutto dell’immaginazione di Eyal, una serie di attività che ha compiuto prima di arrivare al cimitero, o che forse compirà subito dopo. E, quando finisce di parlare in pubblico senza perdere la sua posa solenne, lo vediamo scoppiare a piangere, sempre sull’altro piano, quello privato, segreto e immaginario, all’interno della sua macchina mentre si trova in un autolavaggio.
Il suo è stato un discorso bellissimo, capace di sollevare l’animo di chi lo ha ascoltato, ma non è stato – e non sarà – sufficiente. La morte resta insondabile e la religione, per quanto faccia per proteggerci, non può salvarci dall’oblio.
Eyal alla fine lo accetta e sceglie di tornare a vivere: così, quei gattini che proibiva alla moglie di toccare perché poi la madre non li avrebbe più avvicinati, li prende e li custodisce. Sarà lui a crescerli. Perché la vita, non si sa bene per quale motivo, prosegue, e va affrontata.
Alessandro Aniballi, quinlan.it