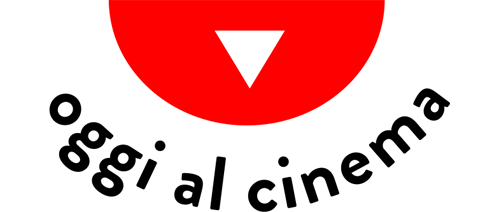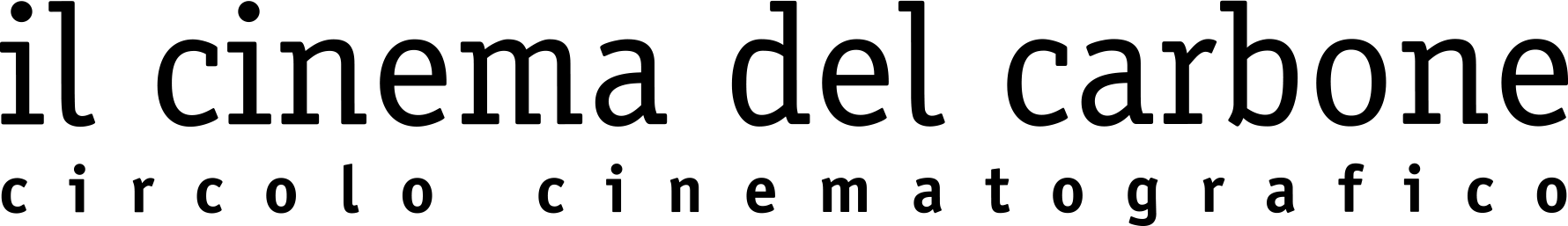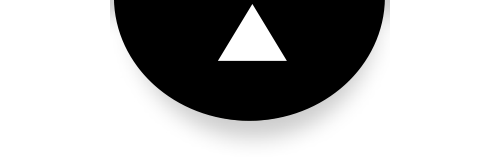E ora dove andiamo?
di Nadine Labaki — Francia/Libano/Egitto/Italia, 2011, 110'
con Nadine Labaki, Claude Msawbaa, Layla Hakim, Yvonne Maalouf
In un paese in una zona montuosa del Medioriente la piccola comunità è divisa tra musulmani e cattolici. Se gli uomini sono spesso pronti alla rissa tra opposte fazioni le donne, tra cui spiccano le figure di Amale, Takla, Yvonne, Afaf e Saydeh sono invece solidali nel cercare di distogliere mariti e figli dal desiderio di trasformare i pregiudizi in violenza. Non tralasciano alcun mezzo in questa loro missione, ivi compreso far piangere sangue a una statua della Madonna o far arrivare in paese delle ballerine da avanspettacolo dell'Europa dell'Est affinché i maschi siano attratti da loro più che dal ricorso alle armi. Si arriva però, nonostante tutto, a un punto di tensione tale in cui ogni tentativo di pacificazione sembra ormai inutile.
Quando la realtà è troppo dura e cupa per essere raccontata in maniera realistica, allora può venire in aiuto la favola, la trasfigurazione fantastica, capace di parlare di cose tragiche con inediti tocchi di leggerezza. È la strada scelta da Nadine Labaki per il suo nuovo film, E ora dove andiamo?, presentato al festival di Cannes e poi premiato dal pubblico a Toronto.
L’ambientazione è perfettamente realistica: un villaggio semi-isolato dal resto del Paese per via delle mine inesplose che rendono impraticabili le terre circostanti e per colpa di un ponte semidistrutto. Una specie di «isola felice», miracolosamente salvata dalla guerra tra cristiani e musulmani che insanguina il resto del Paese, senza vere coordinate geografiche ma abbastanza facilmente riconducibile al Libano e alla guerra fratricida che lo insanguina. E che insanguinerebbe anche questo paesello, dove la chiesa si affaccia sulla stessa piazza su cui c’è la moschea, se non fosse per lo sforzo congiunto delle donne delle due comunità, molto più sensibili degli uomini ai dolori e ai lutti che porterebbe la guerra.
Il film si apre e si chiude su un funerale e tutto il film è costruito per raccontare come si possa evitare che le due comunità finiscano per scegliere strade opposte. Da una parte i musulmani e dall’altra i cristiani. Una sfida che la regista, anche attrice nei panni della volitiva vedova Amale, affronta mescolando le scelte di stile, proprio come mescola quelle narrative. Lo svela fin dalle primissime inquadrature, dove il corteo funebre delle donne finisce per rispondere più ai richiami della musica che a quelli dei defunti, trasformando così la dolente processione verso i due cimiteri (quello cristiano e quello musulmano) in un balletto coreografato. E lo fa con uno scarto di senso che introduce le scelte di regia della Labaki: utilizzare la musica quando i dialoghi rischierebbero di banalizzare le azioni, per aggirare lo scoglio del realismo e della verosimiglianza, così come i tempi e le battute della commedia riescono a trasfigurare la durezza drammatica della quotidianità.
È una scelta rischiosa, che qualche volta dà l’impressione di una (facile) via di fuga ma che più spesso riesce a moltiplicare e pantografare sentimenti e passioni. Come nella bella scena in cui la cristiana Amale, vedova e proprietaria del bar del villaggio, riesce a «dire» il proprio amore al muratore mussulmano Rabih (Julien Farhat): nella fantasia della regista, solo le note e i versi musicali sono capaci far superare gli ostacoli di una cultura e una tradizione che non concepisce amori interrazziali.
E così, tra uno squarcio musicale e un’invenzione surreale (c’è anche un «miracolo» della Madonna), il film riesce a iniettare nuova vitalità a un’idea non nuovissima, quella dell’innato pacifismo femminile di fronte alla bellicosità maschile. E lo fa evitando ogni possibile caduta nel moralismo e nella correttezza politica ma finendo per prendere di mira proprio il nocciolo della questione medio-orientale: l’apparente impossibilità di convivenza tra etnie e religioni diverse. Per questo alcune delle trovate più riuscite del film finiscono per chiamare in causa la fede e alcuni dei suoi simboli, senza i quali il film darebbe l’impressione di voler chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Come nel finale che ribalta le prospettive per costringere i personaggi del film (ma anche gli spettatori) a misurarsi fino in fondo con il nodo della propria identità.
In mezzo succede di tutto, di divertente e di tragico, di doloroso e di allegro, dalla visione collettiva dell’unica televisione del villaggio (nell’unico punto in cui l’antenna può cogliere il segnale) all’arrivo di un gruppo di bellezze ucraine, «affittate» dalle donne del villaggio per distrarre i loro mariti dai venti di guerra.
Ma è soprattutto il senso dell’operazione che colpisce e fa superare qualche inevitabile slabbratura: rileggere la cronaca più dolorosa della propria terra (la Labaki è libanese) con la voglia di trovare un altro modo di pensare e di agire, capace di spezzare i troppi luoghi comuni che ingessano le scelte quotidiane e ossessionano i cuori e le mente di troppe persone. Chiamando in causa la fantasia dove altre qualità hanno finora fallito.
Paolo Mereghetti
Corriere della sera
In collaborazione con il Gruppo 7 - Donne per la pace e con Donne degli Horti