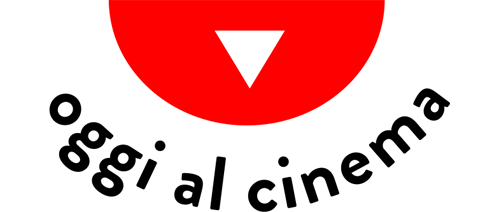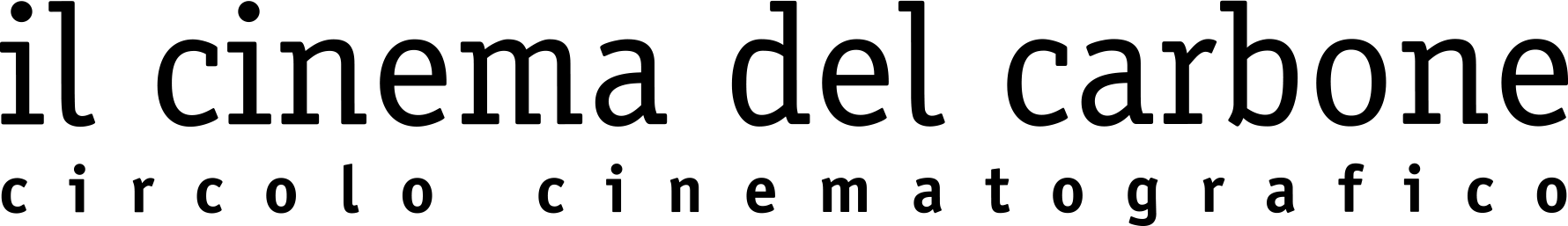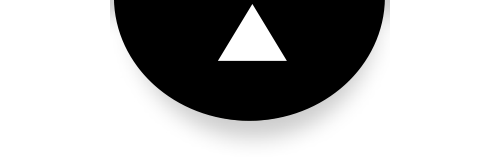10 marzo 2026
Lady Nazca: l'ossessione di una donna per uno dei misteri dell'umanità
C’è un momento in cui cambia tutto, in questa storia di memorie antiche e ossessioni moderne. Un primissimo piano in cui vediamo nel volto e negli occhi di una giovane donna apparire questa ossessione che, riusciamo a intuire subito, le cambierà la vita per sempre. Il tutto avviene quando, durante un viaggio lavorativo senza particolare importanza, si trova insieme al suo capo a viaggiare per l’entroterra desertico del Perù e vede, per la prima volta, delle linee millenarie tracciate nel terreno, una testimonianza archeologica unica, fra le più incredibili della storia umana. La giovane donna si chiama Maria Reiche, è originaria di Dresda, ma diventerà celebre come Lady Nazca, in questa storia su come una giovane insegnante di matematica espatriata a Lima, in Perù, è diventata una delle archeologhe più celebri.
Siamo infatti nel paese sudamericano nel 1936, proprio mentre dall’altra parte del mondo, nell’Europa da cui provengono i protagonisti di questa storia, ancora di più in Germania, l’aria è irrespirabile, il nazismo è consolidato e la guerra sembra vicina. Maria è un’espatriata in cerca di una vocazione, sembra poter essere la matematica, ma è più che un altro un mezzo per lasciare l’Europa e proseguire la ricerca comune a ogni giovane affamato di futuro. È proprio la sospensione temporale di una comunità di europei visti per una volta altrove, proprio mentre il loro mondo stava andando in fiamme, uno dei pregi nell’atmosfera creata in questo film da Damien Dorsaz, attore che ha nella sua storia personale un’altrettanto grande passione per il Perù, che già aveva raccontato di questa eroina poco conosciuta in un documentario una ventina d’anni fa.
Un’ossessione che si specchia in quella di Maria, che l’ha portato a esordire con questa storia che si concentra sui primi anni di una lunga vita dedicata a Nazca, permettendogli di delineare il ritratto di ostinazione di una donna che dovette lottare non poco per essere presa sul serio, per superare i gretti interessi del momento di molta classe politica locale, disinteressata a proteggere quella terra dalle speculazioni. E nel farlo trova un linguaggio comune con le popolazioni indigene che da quelle parti ancora vivono in maniera non molto diversa da secoli. I veri eredi della civiltà Nazca, che prosperò in quella regione un paio di migliaia di anni fa, oltre che di quegli Incas che raccolsero il testimone della loro profonda conoscenza dell’astronomia e dell’ingegneria.
Un viaggio capace di armonizzare il coraggio personale di una donna con uno sguardo epico su un mondo postcoloniale seducente, mentre la polvere del deserto si insinua fino allo sguardo dello spettatore, grazie anche all’interpretazione dell’emergente Devrim Lingnau nei panni di Maria Reiche, che fa emergere la forza e l’energia di una missione impossibile diventata ragione di vita, cercando di preservare le tracce di un lontano passato, rendendolo vivida testimonianza condivisa per un giovane Paese.
Mauro Donzelli, Comingsoon

04 marzo 2026
Ispirato e dissacrante, premiato alla Settimana Internazionale della Critica: Paul & Paulette take a bath
“E noi che sapore abbiamo, Paul?”
È la provocazione finale che la disinvolta Paulette rivolge al giovane amico incontrato, pochi mesi prima in un boulevard parigino. La messa in scena del ghigliottinamento di Maria Antonietta di Francia aveva innescato una travolgente amicizia, bizzarra e morbosa, che si sostanzia di un gioco tanto perverso quanto eccitante: rimettere in scena in prima persona cruenze e massacri storici nei posti dove sono avvenuti. Tra l’appartamento bavarese di Hitler e il Bataclan si sviluppano le bizzarrie, le fughe in avanti e i ritorni di due strambi giovani alla ricerca di affetto e comprensione. Un’amicizia travolgente che sembra preludiare all’amore perché se l’immobiliarista Paul, fotografo rinnegato, che s’intrattiene anche con la capa d’ufficio, s’innamora di Paulette, la ragazza ama, invece, Margherite.
Tuttavia, se la mente corre subito, nonostante le differenze d’età ad Harold & Maude, per Jethro Massey (anche sceneggiatore del film) la commedia di Ashby rimane solo un’architrave innestare e variare questa rom-com itinerante, folle, necrofila e vitale a tinte chiaroscurali che per un tratto cede il passo anche al più classico dei road movie. Oltre lo scandaglio psicologico dei due giovani, fulcro polemico della storia è anche e soprattutto la latente omofobia che percorre e separa tuttora le generazioni nella Francia (e nell’Occidente) contemporanea: Paulette ha reciso ogni legame con la madre e il padre da quando hanno misconosciuto e rinnegato la sua natura saffica. E il nuovo incontro con i genitori non farà che acuire incomunicabilità, malessere e discriminazione.
Disinvolta e atrabiliare, fascinosa e bisognosa d’affetto, il personaggio incarnato da una estrosa, poliedrica Marie Benati è tra i più felici di una sceneggiatura in sé ricca, approfondita e sfaccettata, capace di attraversare le epoche e rielaborare i linguaggi per rivestire di verosimiglianza e tridimensionalità i due personaggi principali, presi nella singolarità di passioni (la fotografia per lui, Elvis Presley e Marylin Monroe per lei) e stranezze.
Il pas de dieux, così, che rimembra alla lontana anche certe sospensioni narrative, e deambulazioni da Nouvelle Vague, si rivela ben recitato e vibrante nelle oscillazioni continue tra momenti di grazia e attimi di sprofondo, tra il vitalismo perverso e la vena necrofila che sostanzia la vita dei ragazzi, capaci di creare un rapporto tanto singolare quanto totale: sensoriale, epidermico, affettivo, (sapio)sessuale, platonico. Un legame che sorvola incasellamenti e definizioni di sorta.
Merito anche di una regia equilibrata, dallo spirito dissacrante, che sa modulare i vari registri espressivi, tenendo l’humour come Azimut, mentre si fa apprezzare il riuso di foto d’epoca sin dai titoli di testa in senso tanto espressivo quanto narrativo (il montaggio è a cura di Julien Chardon) a rendere presenti e alleggerire insieme il carico di violenze, massacri e cruenze della Storia.
Davide Maria Zazzini, Cinematografo

03 marzo 2026
La mattina scrivo è una splendida riflessione sul precariato dell’arte
Suona come un paradosso, ma raramente il cinema riflette sulle difficoltà materiali dei lavori creativi. C’è una sorta di pudicizia che circonda queste professioni, ulteriormente ingrossata da un sistema economico che, pur scambiando il valore umano per quello monetario, ritiene sconveniente (se non volgare) parlare di soldi in modo diretto. Eppure, chi fa cinema vive tali problemi ogni giorno, ed è per questo che la Settima Arte – come tutte le professioni artistiche – richiede spesso un buon “paracadute” familiare sulle spalle. La classe operaia andrà pure in paradiso, ma difficilmente riesce ad accedere a un set, quantomeno non in ruoli decisionali.
La mattina scrivo di Valérie Donzelli, premiato per la sceneggiatura a Venezia 82, ha il merito di sollevare la questione con straordinaria franchezza, usando la letteratura come sineddoche di ogni mestiere creativo. Alla base del film c’è il romanzo semi-autobiografico di Franck Courtès, che riversa la sua esperienza personale nelle vicende del protagonista: Paul Marquet (Bastien Bouillon) ha lasciato la sua fruttuosa attività di fotografo per dedicarsi alla scrittura, ed è riuscito ad affermarsi con due libri molto apprezzati dalla critica. Purtroppo, però, le vendite non sono state altrettanto buone, e inoltre il suo terzo romanzo viene rifiutato dalla casa editrice Gallimard, che peraltro gli ha già pagato un anticipo. L’editor Alice (Virginie Ledoyen) gli chiede di riscriverlo, ma intanto Paul ha bisogno di guadagnarsi da vivere: i suoi risparmi sono agli sgoccioli. Quando l’ex moglie (interpretata dalla stessa Donzelli) si trasferisce a Montreal con i figli, lui è costretto a lasciare il loro vecchio appartamento, trovando casa in un monolocale interrato. Comincia da qui la sua nuova vita: Paul si iscrive a Jobber, una piattaforma per lavori occasionali dove i candidati si sfidano in un’asta al ribasso per ottenere gli incarichi più disparati, e «un euro di differenza nel prezzo può farvi perdere un lavoro».
Tra cantine da svuotare, prati da tagliare e altro ancora, l’app determina la reputazione degli iscritti con un sistema di valutazione a stelline, emblema di quella gamification che va ben oltre le fantasie di Black Mirror. Già Ken Loach aveva trattato l’argomento nell’ottimo Sorry We Missed You, mostrandoci la disumanizzazione del lavoratore nell’era digitale, assoggettato alle leggi della macchina. Donzelli sposta però la focalizzazione sul mondo dell’arte, e sulla sua pressoché totale assenza di garanzie. Quella vissuta da Paul è una diversa forma di precariato, difficile da comprendere per chiunque non sia guidato da una passione silenziosa. Il padre e la sorella del protagonista sono i primi a non capire: trovano assurdo che Paul abbia lasciato la fotografia – da cui guadagnava bene – per darsi anima e corpo a un mestiere così incerto. La dolcezza di Bastien Boillon riflette la personalità compassata del personaggio, il suo garbo malinconico ma determinato, che resiste tanto alle critiche della famiglia quanto alla scorrettezza dei clienti.
Donzelli ci regala così un ritratto commovente, dove la radicalità di una scelta esistenziale, fedele ai propri valori, si accompagna a una solitudine forse inevitabile, connaturata alla scelta stessa. Del resto, la regista francese ama raccontare storie profondamente umane che mettono in discussione il confine tra arte e vita, come aveva fatto nel memorabile La guerra è dichiarata: anche Courtés e il suo “doppio” usano l’arte per tematizzare loro stessi, le loro difficoltà e gli ostacoli che devono affrontare. «Tra il mio lavoro di scrittore e quello di manovale, non ho più un ruolo preciso nella società» commenta Paul, sprofondato in uno strano limbo dove lavoro povero e lavoro creativo finiscono per convergere. La sceneggiatura di Donzelli e Gilles Marchand, in effetti, ha anche questo pregio: mostra la rapidità del declassamento sociale in un sistema basato sul denaro, incapace di riconoscere una funzione a chi non produce ricchezza. In tal senso, scrittore e manovale confluiscono, poiché il primo fa un’arte di nicchia e anti-spettacolare, mentre il secondo è considerato solo un ingranaggio senza volto. [..]
Evidentemente qualcosa si muove nel cinema europeo, sul dialogo fra arte e vita. La mattina scrivo, come il recentissimo Tienimi presente, riporta il discorso sui lavori creativi ai suoi aspetti pragmatici, evitando i rischi dell’idealizzazione.
Lorenzo Pedrazzi, Screenweek

25 febbraio 2026
Tienimi presente: il cinema italiano riparta da Alberto Palmiero
Tienimi presente racconta di desideri giganteschi e di mondi piccoli. Racconta di scelte, di rinunce, di fughe e di tormenti. Tieni presente dell'esordiente Alberto Palmiero racconta di lui, scalcinato (aspirante) regista, ma anche di noi. Inguaribili sognatori fatti a pezzi da una vita che gioca sporco, che interroga senza mai rispondere. Pone l'accento sulla generazione di chi ha trent'anni, troppo in là con l'età, ma ancora troppo in dietro secondo gli standard di una società imposta e non corrisposta. E sì, senza dubbio i produttori Simone Gattoni e Gianluca Arcopinto c'hanno visto lungo nel talento di Palmiero, che oltre alla regia firma il soggetto e la sceneggiatura (insieme a Davide de Rosa) di un film che, senza strafare, si potrebbe addirittura considerare neorealista.
Nel film, la vita e il cinema si confondono. Si mescolano, come se fossimo in un film di Woody Allen (quello degli esordi, però). Ma ad Alberto, interpretato dallo stesso Palmiero, il cinema "l'ha deluso". Sembra di sentire Carlo Verdone ne La grande bellezza, quando se ne va da Roma, stufo di una città che promette e non mantiene. A proposito: Carlo Verdone, oltre ad un certo Troisi, pare sia l'altra diretta influenza del regista. Alberto è casertano (di Anversa), ma trapiantano nella Capitale. La birretta a San Lorenzo, la pasta al pomodoro, il Centro Sperimentale, l'accredito alla Mostra del Cinema di Venezia, per fare rete, per farsi vedere.
Ma le cose non girano. La speranza di fare un film svanisce nell'ennesima telefonata che non arriva. Ad Alberto non resta che tornare giù, a casa da mamma e papà (interpretati dai veri genitori del regista, strepitosi), rifugiandosi nella "vita lenta" di una provincia dai contorni netti. Con lui gli amici di sempre, una ragazza appena conosciuta (Gaia Nugnes, che è la ragazza del regista) e un simpatico cagnolino che lo segue ovunque (Johnny, il cane del regista). La quiete, però, dura poco. Almeno per chi sogna in grande, almeno per chi accetta di affrontare i propri dubbi, sfruttandoli per ricominciare.
Lo ha scritto direttamente Palmiero nelle note di regia: "Tienimi presente nasce da un periodo piscologicamente complesso". Con coraggio, miscelando l'umorismo alla frustrazione, il regista realizza un film a conduzione famigliare, scritto seguendo un'idea istintiva, capace di elaborare gli episodi realmente vissuti. Perché sì, affrontare i propri demoni e i propri dubbi non è mai facile, e ci vuole carattere per trasformare la difficoltà in una forza motrice. Girato con una troupe ridotta al minimo indispensabile (nonostante il supporto di Marco Bellocchio e Francesca Calvelli), il film identifica con lucidità e sincerità quel cosmo compresso di ragazze e ragazzi che si portano dietro l'ingombrante fardello di non volersi accontentare, dimostrando di esserci e di esistere, di meritarsi quel sogno chiuso in un vecchio cassetto. Nonostante tutto.
In mezzo c'è il fatidico posto nel mondo da trovare, e pure da difendere. Quel punto di partenza e quel punto d'arrivo di un viaggio sconnesso e leggero, segnato dallo sconforto di un trentenne come tanti, perfetto rappresentate di una generazione spaesata, abituata a vivere sull'orlo del precipizio. Perché la parola d'ordine è precarietà. Oggi c'è, domani chissà. Tienimi presente, dal tono allegro e scanzonato ma segnato dalla malinconia e dall'ansia, dimostra con intelligenza ed efficacia quanto i trentenni abbiano molte cose da dire. Cose interessanti, mai banali, quasi rivoluzionarie. Senza dubbio cose normali. Quella normalità sempre più rara in un cinema borghese che cerca a tutti costi l'effetto, ignorando una realtà ammaccata e disillusa che, però, non perde mai la voglia di sorridere.
Damiano Panattoni, Movieplayer

25 febbraio 2026
L’agente segreto, il magico cinema “da cinefili” che è diventato di tutti
Ci sono tanti prima e dopo, nel cinema recente, ma uno inconfutabile è senza dubbio costituito da Parasite, e l’effetto che, lui sì, di certo ha generato su scala larghissima. Effetto generato da una più strisciante e sempre più generalista K-vague, che si direbbe culminata quest’anno con KPop Demon Hunters, il film più visto nella storia di Netflix (quasi 500 milioni di visualizzazioni, stando ai dati della piattaforma, in sei mesi). Effetto simbolico, a volte forzato, altre seguito solo per notiziabilità (scusate la brutta parola). [...]
Quest’anno, fra i dieci candidati ci sono il devastantemente bello (cit. di un’amica mia) Sentimental Value del norvegese Joachim Trier (ne ho scritto qui) e L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho, un altro prodigioso brasiliano che finora era stato relegato alla cinefilia festivaliera. Nove candidature per il primo, quattro per il secondo, ma tutte “pesanti”. Gli Oscar valgono quel che valgono, ma valgono: per copertura, eco, notiziabilità (again). E vale ancora di più il fatto che anche a Hollywood si siano accorti (ben svegliati!) soprattutto dell’Agente segreto e del suo autore. (Trier era già stato nominato nel 2022 per La persona peggiore del mondo, nelle categorie miglior film internazionale e miglior sceneggiatura originale).
Mendonça Filho è un autore grande che fa un cinema altrettanto grande, ma col passo di chi fa artigianato minuto. È uno che, guidando un’Ape car, vince una gara di Formula 1. Sono stati così i suoi film precedenti: Il suono intorno, Aquarius, Bacurau, il documentario Retraros fantasmas. Opere sontuose viste poco o male qui da noi, che giocano con i generi (Bacurau è di fatto un horror, Aquarius gioca con il mélo), incantano, sconcertano. Storie private che raccontano l’ammaloratissimo lato pubblico di una società, quella brasiliana, che un horror lo è per davvero.
Mendonça Filho è un oppositore dei governi che però sceglie di mettere la denuncia dentro storie che sembrano un grande romanzo popolare e quasi magico, politico ma senza bisogno di comizi, ribelle restando classico. Attorno a una casa sul mare a cui una monumentale Sônia Braga restava attaccata in Aquarius ruotava la tragedia di un Paese espropriato del suo volto urbanistico, economico, culturale, dunque della sua stessa Storia.
L’agente segreto ha lo stesso passo. È un thriller politico anni ’70, un atto d’accusa contro le dittature militari che vogliono cancellare la memoria dei popoli, una saga famigliare, una commedia umana. In realtà non c’è nessun agente segreto, ma solo un ingegnere (meraviglioso Wagner Moura, giustamente riconosciuto anche lui dall’Academy) anche lui anti corruzione delle istituzioni che torna a Recife per ritrovare suo figlio. C’è una comunità guidata da una pasionaria di buon cuore (che portento la rivelazione – a quasi ottant’anni! – Tânia Maria) in cui si ritrovano esuli, reietti, non allineati (che piangere la scena nel sotto-finale che li raduna tutti).
È un dramma politico che incastra chi vuole cancellare il passato, uno studio etnografico, un B-movie anni ’70 (la miracolosa gamba assassina, in quello che sembra un piccolo corto dentro un film lunghissimo: 160 minuti di cui però non ci si accorge). Un film sulla memoria politica, esistenziale, umana che ci riguarda tutti (vedi il finale, che ovviamente non vi dirò). E anche una storia personale del regista che diventa di tutti. Così come il suo cinema.
Che ci interessino o meno gli Oscar, c’è un prima e un dopo anche solo guardando questi film. La casa dei sussurri e delle grida di Joachim Trier, la mappa di un intero Paese su cui si muove sinuosamente e fantasticamente Kleber Mendonça Filho. Correte al cinema, finché ce n’è.
Mattia Carzaniga, RollingStone

23 febbraio 2026
Lo scuru: dal romanzo di Labbate l’audace esordio del giovane (e siculo) Lombardo
Non è l’oscurità a disorientare in Lo scuru: è la mancanza di una “realtà”, di un fuori, affidabile.
Giuseppe W. Lombardo, classe ’94, alla sua prima regia di un lungometraggio sceglie di adattare il nerissimo romanzo di Orazio Labbate e di adottare il punto di vista del suo protagonista, un giovane uomo affetto da schizofrenia, tornato in Sicilia per capire se davvero “il male” che lo ha reso un emarginato sia soltanto patologia, o se affondi in un terreno più antico, fatto di spiriti, superstizioni e “cosi tinti”.
Un viaggio all’origine del dolore che finisce per confondere identità, fede e memoria con “il respiro stesso della terra siciliana”.
Senza concedere allo spettatore nemmeno quella struttura indiziaria che, ad esempio, in Spider di Cronenberg organizzava la mente fratturata di Raph Fiennes come un giallo interiore, Lo scuru costringe a stare dentro il labirinto psichico rifiutandosi di decifrarlo. E lo fa in parallelo sia sul piano narrativo che su quello estetico.
Se il racconto è ovunque aperto, scritto come se fosse sempre in controcampo rispetto a un piano che non scorgiamo mai, e la Sicilia anziché fornire ancoraggi presenta incessantemente risvolti, matrioska di ambiguità, tutto il percepibile – inquadrature, luce, suono – finisce per riprodurre soglie, spazi di collisione e di attraversamento tra ciò che è reale e ciò che è vissuto come reale. In questa voluta confusione tra psicologico e spirituale, il film indaga “quel luogo misterioso dello spirito” dove credo e ragione, scienza e superstizione, non si elidono ma si avvinghiano, si mordono, somigliano a una cosa sola.
Un attorcersi l’uno all’altro, come il bianco e il nero di plastica drammaticità che Sara Purgatorio regala al film, in uno spettro dei grigi che evoca quel gotico siciliano che è la cifra estetica e antropologica del progetto. Neri che ingoiano profondità e bianchi abbacinanti, conviventi nell’ombra che avvolge tutto nel dubbio e nella macerazione.
Una Sicilia così l’abbiamo vista forse nelle fotografie di Ferdinando Scianna, tra i tralicci, i pontili e le strade deserte di un paesaggio insulare incongruo e postindustriale.
Una scena futurista e arcaica, impreziosita dalla partitura minerale di Santi Pulvirenti, su cui si stagliano i corpi opachi di Fabrizio Falco, Simona Malato, Vincenzo Pirrotta, Filippo Luna, Daniela Scattolin e un ineffabile Fabrizio Ferracane.
In filigrana, Lo scuru – che ha debuttato in anteprima assoluta allo scorso Tertio Millennio Film Fest – dialoga con la letterarietà siciliana “notturna” di Bufalino e con le liturgie di una religiosità clandestina, fatta di croci e di fatture, di devozioni e riti pagani, statue di santi e superstizioni. Anche questo è cortocircuito. [...]
A dispetto delle inevitabili spigolosità, Lo scuru ha una virtù rara nel cinema italiano degli esordi: l’ambizione. A 31 anni, Lombardo firma un’opera prima con una postura autoriale che, a dispetto del titolo, è assai chiara. E che nel rivendicare “il gotico siciliano”, ovvero un altro immaginario possibile dalle parti di Scilla e Cariddi, vuole riposizionare il genere nel perimetro del visivo, più che del narrativo. Comunque vada, chapeau al coraggio.
Gianluca Arnone, Cinematografo

10 febbraio 2026
Il ‘Sentimental Value’ delle case che abitiamo
Ogni tanto la nonna elenca in modo malinconico i mobili della sua vecchia casa. Se mia madre è nei paraggi, segue il solito battibecco, Perché li hai dati via allora, se poi devi farmi una testa così?
Non pensavo li volessi.
Ti ho mai detto questo?
In ogni caso, è andata come è andata.
Gli antropologi di Ayşegül Savaş è un bel romanzo ora molto di moda che racconta di una coppia di fuori sede in una città imprecisata alla ricerca di una casa. La casa è, ovviamente, metafora di molte più cose, e di cose grandi e piccole è pieno il libro. Vasetti comprati al mercatino delle pulci, spezie per insaporire piatti che ricordano posti lontani, lampade, giacche, libri, fogli di giornale. E quei mobili della nonna perduti, forse finiti in altri mercatini. Tutto ciò che compone le nostre vite piccole che vogliamo credere grandi perché sappiamo come arredarle.
Su una casa si apre Sentimental Value, il magnifico film di Joachim Trier candidato ieri a nove Oscar. È una casa che vive e che muore. Che scricchiola e che si rompe. Che accoglie risate, baruffe, nascite, addii. È una casa dove, di tanto in tanto, qualcuno torna a riprendere qualcosa che aveva lasciato: anche qui un vaso, o le casse di un vecchio stereo.
Ma, soprattutto, in quella casa si vanno a riprendere le persone lasciate indietro, che lo vogliano o no. In quel villino di legno rosso nel centro di Oslo il papà regista (Stellan Skarsgård) immagina, dopo tanti anni, un nuovo film solo perché le figlie – una attrice (Renate Reinsve) che lui vorrebbe finalmente dirigere, l’altra archivista (Inga Ibsdotter Lilleaas) che va a cercare in altri oggetti, foto, diari, registri, i segreti di famiglia – possano credere ancora nella vita di quella famiglia. La messa in scena serve, forse, a svelare la realtà.
Trier e il suo sceneggiatore Eskil Vogt sono antropologi per davvero, e da sempre (Reprise, Oslo, 31. august, Thelma, La persona peggiore del mondo) usano quelli che apparentemente sono dettagli – ninnoli, soprammobili, accessori psicologici ed esistenziali – per costruire un mondo: il loro, il nostro. E così il cinema di Trier è diventato una casa da abitare, e che riconosciamo di film in film anche se cambiano gli ospiti, e la disposizione dei mobili, e la luce entra in modo diverso – e, a un certo punto, comunque ti acceca.
Anche qui che sembra tutto scuro. Ci sono un padre e una figlia, in particolare, che non si parlano più. Una scia di litigi, abbandoni, tentati suicidi, funerali. Tutto in quella casa che cambia – la vediamo dall’inizio del secolo a oggi, attraverso una voce narrante che sembra quella della casa stessa – e che resta a testimoniare l’immutabile storia di quella famiglia, di tutte le famiglie.
Trier ha – letteralmente – costruito una casa che sta dentro la sua (e la nostra) casa più grande, che è il cinema. Ingmar Bergman è una sua ispirazione inevitabile da sempre, e qui ancora di più. Perché il film – e il blackout di Nora (nomen omen), il personaggio di Reinsve – inizia dal teatro. Per quei volti sovrapposti dal montaggio che sono un esplicito rimando a Persona, come a sgomberare il campo da eventuali “hai copiato!”: ve lo dice lui per primo. Per un certo spiritismo che anima le storie dei vivi e dei morti, che si confondono continuamente. Per quel che è lecito mischiare – e rubare, divorare, violare – tra arte e vita che è parte di tantissimo cinema di Bergman, da Il posto delle fragole a Sinfonia d’autunno, e anche della sua vita stessa. L’altra sera sul palco degli EFA, i cosiddetti Oscar europei, c’era Renate Reinsve accanto a Liv Ullmann, e sembrava che il tempo si fosse fermato, che fossero parte di un unico film, abitanti della stessa casa nello stesso momento.
Ma Sentimental Value sono anche altre case cinematografiche in senso letterale. Il design porn inconsapevole di certi appartamenti parigini (o delle maison di campagna) di Rohmer. O le famiglie divise e riunite dietro le pareti di carta di riso di Ozu. O gli appartamenti newyorkesi di Woody Allen: anche in questo villino norvegese, dopotutto, si possono ascoltare di nascosto le confessioni dei pazienti della mamma psicanalista, attraverso la stufa che comunica con la stanza accanto.
Joachim Trier è da sempre un regista classico, ma mai nostalgico. Ha l’occhio sul presente e la sua umanità de-generata (vedi La persona peggiore del mondo), e anche se in Sentimental Value si affida a luoghi che sono simbolicamente e volutamente analogici – il palcoscenico, una biblioteca, un’idea di cinema che è appunto novecentesca (con tanto di sberleffo all’ossessione per i moodboard e ai registi passati su TikTok) – non si avverte mai il peso del passatismo.
Nemmeno nel finale. C’è quello che riguarda i vari personaggi e i loro prodigiosi interpreti – il padre, le sorelle, l’attrice americana (Elle Fanning) arrivata su quel set finto/vero, e tutti i fantasmi del passato – e c’è quello che riguarda la casa in cui questa storia è ambientata. Ed è, tra tutti, il più straziante. Non vi dico come diventa quella casa – che abbiamo visto affollata, sgangherata, disordinata, in una parola: abitata – alla fine di Sentimental Value. Se è più bella all’inizio o alla fine. Se dentro ci sono ancora i mobili della nonna. È solo una questione di valore affettivo, che è la cosa, nella gioia e nel dolore, a cui questo film chiede di non abdicare mai.
Mattia Carzaniga, RollingStone

09 febbraio 2026
Pillion: un viaggio lucido, divertente e bellissimo in un sottobosco della comunità omosessuale non troppo raccontato
Pillion - Amore senza freni, il nuovo film di Harry Lighton al cinema dal 12 febbraio, è di una bellezza e di un'intensità disarmanti, perché non solo racconta l'incontro di due ragazzi diversissimi per temperamento e atteggiamento, ma anche un tema molto poco frequentato e ancora intasato di tabù come il sesso come dominazione e controllo.
Il film, presentato in anteprima a Cannes dove ha vinto il premio Un Certain Regard per la migliore sceneggiatura, ha come protagonista Harry Melling che tutti ricorderete come il cugino Dudley nella saga di Harry Potter: qui lo ritroviamo più magro, meno spilungone e decisamente più impaurito, deciso a condurre una vita alquanto passiva in un’anonima città del Regno Unito dove vive insieme ai genitori. Le cose cambiano quando Colin, questo il nome del suo personaggio, ancora tristemente incerto sul posto che occupa nell’ecosistema gay, incontra al bar un uomo avvenente e sicuro di sé che non passa certo inosservato. Con grande sorpresa di Colin l’uomo - come scopriremo in seguito, un appassionato di motociclette di nome Ray, interpretato da Alexander Skarsgård - si avvicina e, sorprendentemente, gli passa un biglietto con un messaggio stringato che gli indica dove e quando incontrarlo la sera successiva, ovvero il giorno di Natale. Inizia, così, una specie di improbabile storia d’amore, o corteggiamento, o accordo contrattuale che vede Ray e Colin in due posizioni opposte, il primo come dominatore e il secondo come dominato considerando che, per far sì che la relazione funzioni, Colin fa tutto quel che gli viene detto, impaziente di accondiscendere agli ordini di questo adone autoritario le cui istruzioni burbere e impassibili sono al tempo stesso eccitanti e minacciose.
Mentre i genitori di Colin, la madre malata (Lesley Sharp) e il padre incoraggiante (Douglas Hodge), sono sempre più confusi man mano che Colin si sottomette a questo misterioso motociclista al punto da cambiare abbigliamento, aspetto e comportamento, Colin inizia a volere di più, cominciando a guardare Ray non solo con gli occhi di un dominato in perenne adorazione ma anche di un ragazzo che sogna di essere amato. Sospendendo miracolosamente ogni giudizio su quello che vediamo sulla scena, Pillion non getta alcuno sguardo pruriginoso o minaccioso su una sottocultura come quella delle pratiche sessuali non convenzionali, scegliendo un approccio più riflessivo e compassionevole, che non edulcora né ignora la vera natura della relazione tra Colin e Ray. Pur essendo per certi versi esplicito, il film è di un'onestà e di una franchezza sconcertanti anche solo perché mette sul tavolo una domanda fondamentale: quand’è che una cessione dell’autonomia concordata volontariamente smette di essere del tutto consensuale? Attraverso una comicità sottile - si sorride molto in Pillion - e una lucida rappresentazione di certe norme culturali e sociali di una certa comunità gay - motociclisti, leather daddy e rispettivi partner - questo film è anche profondamente intimo e raffinato perché racconta non solo il percorso di formazione e di cresciuta di un ragazzo, Colin, alle prese ora con l'inquietudine e ora con l'euforia, ma ancora cosa voglia dire per un dominatore severo e trattenuto come Skarsgård tradire la sua natura e lasciarsi andare, suggerendo che dietro il personaggio iper-mascolino e dominatore affondino le radici in un’omofobia latente e autodistruttiva.
Mario Manca, Vanity Fair

03 febbraio 2026
L’autobiografia atipica di Amélie Nothomb in una coloratissima e poetica fiaba d’animazione: La piccola Amélie
“Un nulla che occupa spazio”, “un ortaggio”. Immobile, e onnipotente. Probabilmente è questa la sensazione che prova ogni essere umano nei suoi primi giorni di vita. La stessa che prova la piccola Amélie, narratrice in soggettiva di questo bel film d’animazione diretto da Mailys Vallade e Liane-Cho Han, tratto dal bestseller Metafisica dei tubi di Amélie Nothomb (Voland Edizioni), testo che a sua volta era un’autobiografia sui generis della scrittrice belga, nata nel 1967 a Kobe, in Giappone, da genitori diplomatici.
Ecco dunque che l’opera d’esordio come sceneggiatori e registi di Mailys Vallade e Liane-Cho Han (entrambi con un lungo lavoro di animatori alle spalle) mantiene accesa la fiamma di questo magico viaggio nella dimensione della prima infanzia, restituendone i vividi colori delle scoperte e l’inafferrabile sensazione relativa ai misteri più profondi che, giocoforza, accompagnano un’intera esistenza.
Il morso scatenante, quello che compiuti i due anni la apre definitivamente al mondo (di fatto svegliandola da quella “venerata” apatia) è quello ad una tavoletta di cioccolato bianco che le porta la nonna dal Belgio: la curiosità di Amélie nei confronti della vita esplode, il film ne asseconda in maniera caleidoscopica le innumerevoli emozioni, ne attende – proprio come i genitori e i due fratellini più grandi – la prima parola, la segue poeticamente tra le meraviglie e le insidie di quel bellissimo giardino antistante la casa.
Centrale diventa poco a poco il rapporto tra la bimba e Nishio-san, la giovane tata: è attraverso questo legame, unico e profondo, che tale fiaba di (prima) formazione, sarcastica e a suo modo irriverente, riesce a insidiarsi al di qua dello sguardo (che è di per sé “una scelta, dato che soffermarsi su qualcosa di determinato comporta un’esclusione, un rifiuto”. E “vivere vuol dire rifiutare. Chi accetta ogni cosa non è più vivo dell'orifizio di un lavandino”…), senza ricorrere a facili didascalismi (l’anziana padrona di casa giapponese che non gradisce che la bambina, per lei “straniera”, venga coinvolta nei tradizionali rituali locali), esaltando con delicata naturalezza la magia nascosta dei gesti più semplici. E ragionando sul senso profondo del doversi muovere tra due mondi (quello d’origine, quello di crescita), facendo i conti non solo con le scoperte più elettrizzanti, ma anche con il dolore (la morte), con le ferite che possono essere lasciate da qualsiasi esperienza sulle cose. Proprio perché, appunto, solamente nei tubi le cose passano senza lasciare tracce.
Candidato come miglior film d’animazione ai prossimi Oscar, La piccola Amélie ha vinto il premio del pubblico all’Annecy International Film Festival, il premio per il miglior film europeo al San Sebastián Film Festival, è stato presentato al Festival di Cannes ed ha ottenuto una menzione speciale ad Alice nella Città
Valerio Sammarco, Cinematografo

26 gennaio 2026
La scomparsa di Josef Mengele ci regala il vero volto del male
Tratto dalla biografia di Olivier Guez, uscita nel 2017, “La scomparsa di Josef Mengele” fin dall'inizio si calibra come un racconto cinematografico completamente atipico, sia dal punto di vista estetico che narrativo. Serebrennikov decide di alternare passato e presente, di seguire l'invecchiamento di Josef Mengele, il suo vagare eterno e allucinato tra Brasile, Argentina, Paraguay, che a poco a poco lo spinge quasi alla follia. La straordinaria fotografia di Vladislav Opelyants alterna un bianco e nero elegante, freddo, con il colore, usato però abbastanza sporadicamente e soprattutto sempre in contesti e momenti molto precisi. La sua regia è dinamica, stretta, segue come un segugio i passi di un uomo tra i più contorti, inquietanti, odiosi e spezzati che si siano mai visti. “La scomparsa di Josef Mengele” ce lo mostra nell'Argentina seconda patria dei nazisti, tra svastiche, celebrazioni bellicose, matrimoni combinati e ricchezza. Poi però ecco che Israele comincia a dare la caccia ai gerarchi impuniti, e Josef è costretto, da facoltoso medico, a spostarsi cambiando pseudonimo, finendo dentro un gorgo asfissiante, sempre nel terrore che chiunque sia un nemico, che la punizione arrivi.
Ma chi era Josef Mengele? Se lo chiede lo spettatore, desiderando andare oltre i cliché, ma se lo chiede anche Rolf (Maximilian Meyer-Bretschneider) il figlio che lo va trovare quando ormai è sempre più vicino alla demenza, perso nei suoi sproloqui autoassolutori, nella giustificazione degli orrori che ha commesso, nell'idea che chiunque, fuori da quella catapecchia in cui vive come uno scarafaggio, sia comunista o ebreo. Non può che venire alla mente “La zona d'interesse” di Jonathan Glazer, altro film straordinario e opprimente, altro sguardo dell'orrore dal punto di vista del carnefice. Benché diverse, le due opere sono accomunate dal farci arrivare tutta la banalità, tutta la vuota arroganza, di due omuncoli incaricati di infliggere sofferenze, elevati oltre le loro possibilità da un sistema marcio, un culto sado-maso-mortuario che Serebrennikov ci mostra in più di una sequenza al limite dell'orrore, davvero difficile da reggere. Ma questa era la verità, su Mengele, sulla Germania Nazista, su ogni totalitarismo ideologico che in quanto vuoto assordante, era usato da ognuno per riempirlo con tutto ciò che voleva, nel modo in cui voleva. Mengele lo riempì con sadismo, crudeltà, narcisismo e una fede incrollabile nell'essere parte di un disegno grandioso e necessario.
August Diehl ci regala un'interpretazione incredibile, magnifica e magnetica. Il suo Mengele è il nazismo fatto e finito, ma soprattutto è autentico, inquietante nelle sue adamantine opinioni fuori dal tempo e dalla Storia. Un lavoro eccezionale col trucco ce lo fa vedere giovane e poi nelle varie stagioni dell'anzianità e la cosa più assurda, è che a un certo punto quasi (quasi) proviamo pena per lui. In Argentina era ricco, circondato dai sopravvissuti del Reich. Già lì però si sente assediato, il Mossad è sulle sue tracce, chiunque potrebbe venderlo. Viene protetto per anni da una rete compiacente, che si dirada poco a poco, mentre lui diventa sempre più misantropo, intrattabile, acido e collerico. Ma poi eccoli lì, alienato in una baracca brasiliana, col figlio che lo viene a trovare e non sa cosa dire, come interfacciarsi con quel padre assassino e torturatore, che rifiuta ogni colpa, rivendica l'orrore come merito. Sempre più povero, sempre più solo, infine sempre più assediato dall'Alzheimer, da una paura irrazionale. No, Josef Mengele non l'ha fatta così franca, pare dirci Serebrennikov, la sua condanna è stata vivere solo, senza amore, nella paura, fino alla fine dei suoi giorni.
“La scomparsa di Josef Mengele” è [...] un film necessario, politicamente attualissimo, nel ricordarci che l'orrore è sempre dietro l'angolo. Soprattutto, ci ricorda l'importanza della giustizia, quanto vaghe amnistie o peggio ancora principi di real politik in nome della Guerra Fredda, abbiano permesso il sopravvivere di orrori impuniti, e quindi la possibilità di una loro reiterazione. Prendendosi la licenza di unire fantasia e realtà, ma sempre secondo una logica di approfondimento del personaggio e dei suoi pensieri, “La scomparsa di Josef Mengele” è più che un biopic tour court, una seduta di analisi con cui cercare di farci comprendere il male assoluto, la sua evoluzione, il suo volto, la banalità dentro le tenebre.
Giulio Zoppello, Today