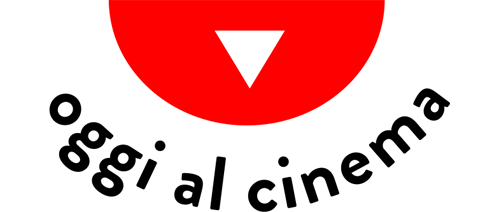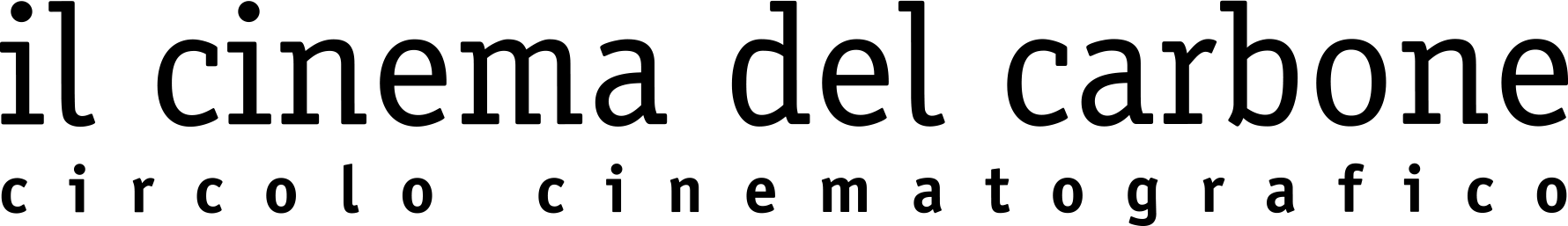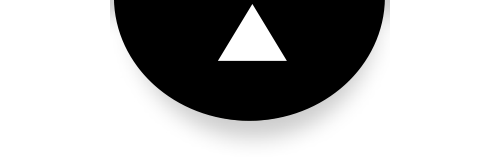14 settembre 2023
Passages di Ira Sachs: un’opera perfetta nel delineare la follia di relazioni amorose tossiche, con tre ottimi protagonisti
Ira Sachs conduce dialoghi e situazioni sul modello del cinema francese (Pialat e Rohmer su tutti) ma lo arricchisce del maladettismo Fassbinderiano soprattutto nella figura di Franz, indeciso sulla propria identità sessuale. L’autolesionismo del giovane tedesco che non sa quello che vuole, lo conduce a vagare con la bicicletta in maniera peripatetica, disperatamente da un lato all’altro della città. Se la bisessualità è uno stato molto fluido che riflette la confusione del proprio rapporto con la sfera affettiva, l’atteggiamento manipolatorio di Franz nei confronti dei suoi amori è specchio di una fragilità emotiva che sfocia in un disturbo dissociativo. Franz vorrebbe applicare alla vita sentimentale le sue regole, come fa quando dirige un film, con atteggiamento dispotico e arrogante. Ma il Cinema non è la vita e Franz si trova a cambiare continuamente oggetto del desiderio perché le persone sfuggono al suo controllo.
Passages non vive solo di questo triangolo queer, è anche una portentosa prova d’attori: oltre all’ormai gigantesco Rogowski capace anche con la cadenza della voce di trasmettere confusione e instabilità, sono da sottolineare le prove in sottrazione degli altri due protagonisti, Adèle Exarchopoulos e Ben Whishaw. La prima amplifica il personaggio interpretato ne La vita di Adele donandole sensualità e maturità (notate i suoi movimenti quando balla o quando mangia). Il secondo fornisce un manuale perfetto di innamorato condotto alla distruzione psicologica da un narciso egocentrico. Martin non riesce a tagliare il cordone ombelicale della dipendenza affettiva e i suoi tormenti sono tutti nei suoi movimenti indecisi, nei lapsus, nella timidezza arresa degli occhi. Non è un caso che la scena più emozionante del film veda Martin e Agathe uno di fronte all’altra, alle prese con le bugie e i doppi giochi di Franz. La sessualità è il mezzo con cui Franz afferma il suo dominio nella relazione triangolare, disarmando gli altri due amanti con una falsa immagine di debolezza. [...] Presentato a Palermo in anteprima nazionale alla 13° edizione del Sicilia Queer Film Fest, Passages è un’opera perfetta nel delineare la follia di relazioni amorose tossiche mostrando tre personaggi in balia di continui spostamenti del centro di gravità affettivo.
Fabio Fulfaro, Sentieri Selvaggi

11 settembre 2023
Emily: uno sguardo inedito sull'esistenza di una delle autrici più misteriose della letteratura
Emily "la strana", l'empia, il “pesce svitato”, Emily la ribelle, la “dark” diremmo oggi, che, dietro un lenzuolo bianco che profuma di lavanda, gioca con l’amato fratello Branwell a colpi di versi.O forse semplicemente la Emily libera, che scioglie i capelli quando corre a perdifiato nella brughiera di vento, lontana dai confini domestici, poetessa precoce alla disperata ricerca di una libertà artistica e di pensiero. La urla, la vive, con “un sacco di storie in testa” e nel cassetto una fantasia fervida e sconfinata. In piena epoca vittoriana, mentre suo padre Patrick, curato perpetuo, conduce le sue sfide contro il peccato e la vorrebbe insegnante, “Em”, come la chiamano i suoi cinque fratelli, imbastisce storie come il mondo immaginario di Gondal, nelle sua testa, o da dietro una maschera, mentre il suo immaginario talvolta inquieta, atterrisce, imbarazza la famiglia, ma senza dubbio salva la ragazzina innamorata della poesia.Chi era Emily Brontë e cosa si nasconde dietro la creazione di un capolavoro come Cime tempestose, l'unico romanzo della poetessa, scritto fra l'ottobre 1845 e il giugno 1846?Diretto da Frances O’ Connor, al suo debutto alla regia, e interpretato dalla bella Emma Mackey, Emily ci porta nell’appassionante vita di una delle scrittrici più amate di sempre, gettando uno sguardo inedito sull'esistenza di una delle autrici più misteriose della letteratura. Lungi dal volere essere un rigoroso biopic, Emily è un film in stretto dialogo con Cime tempestose, dotato di un impianto spiccatamente narrativo, a tratti fiabesco. La regista invita il pubblico a immaginare cosa possa aver ispirato l'autrice a scrivere il suo unico romanzo. La sceneggiatura cede al ricco mondo poetico di Emily Brontë, senza rinunciare alla precisione storica e biografica, ottenendo una storia che, come spiega O’ Connor, è “per metà la sua vita e per metà Cime tempestose, con l’aggiunta di qualcosa di mio”. Profondamente influenzata dalla morte della madre, dai confini imposti dal padre e dalla vita familiare, dal rapporto con le sorelle Charlotte e Anne e dall’amato fratello Branwell, Emily cerca irrefrenabilmente la sua libertà artistica e la trova nelle poesie arrivate fino a noi e nella creazione di uno dei più grandi romanzi di tutti i tempi che compone quando non ha ancora trent’anni. Sulla scena è un personaggio in evoluzione nel rapporto con se stessa, con il fratello e con la famiglia tutta, ma anche con il proprio talento. Inizialmente timida, chiusa e obbediente, alla continua ricerca dell’approvazione paterna, Emily è animata da una grande curiosità. La vediamo acquistare sempre più fiducia in sé e diventare una donna.Attraverso il film ci addentriamo lentamente nell’essenza più intima di Emily Jane, cogliendo quello spirito che al suo tempo sorprese tutti con un libro considerato all’epoca intenso e appassionato. Sin dalle prime scene, il viaggio nell’universo di Emily è un crescendo di sensazioni che tracciano il cammino di una ragazza che si affaccia all’età adulta, alla spasmodica ricerca del proprio posto nel mondo. O’Connor sfonda con coraggio il muro che avvolge “la sfinge della letteratura inglese”, restituendo corpo, carattere, personalità e voce a una figura arcana. E poco importa se alcuni elementi sono il frutto di una libera interpretazione della regista. Colte nella loro quotidianità, le sorelle Brontë, alle quali si è sempre pensato come a scrittrici molto serie, conquistano con i loro atteggiamenti talvolta divertenti e leggeri, nella loro casa di famiglia e fuori. Nel suo racconto, in bilico tra realtà e immaginazione Frances O’Connor dà la parola a Emily sottraendola all’immagine che di lei ha voluto dare la sorella Charlotte che, dopo la morte, ne ha ripercorso la vita da un punto di vista personale e non sempre obiettivo. Il film tocca anche questo rapporto tra sorelle fatto di punti oscuri, un misto tra rivalità, diffidenza, ma anche di profondo amore e affetto devoto. Mentre Emily vive la sua indocilità con maggiore naturalezza, Charlotte si sforza di soffocare i suoi tratti più irrequieti e spigolosi.[...] Del film Emily colpiscono la natura selvaggia intrista di pioggia, con i suoi contrasti di luci e ombre, il paesaggio evocativo della brughiera dello Yorkshire, che si impone sullo schermo con tutta la sua forza drammatica sviscerando la lotta tra la protagonista e la natura. La fotografia di Nanu Segal restituisce tutta l’intensità della potenza naturale del paesaggio. Lontana da toni patinati o sovraccarichi, l’immagine resta realistica, pastosa, con una calibrata connotazione retrò. E infine spazio al look dei protagonisti. Tra le felici intuizioni del costumista Michael O’Connor (è la stessa regista a rivelarlo) c’è quella del vestito stampato a fulmini. “Nella sceneggiatura c’era un riferimento storico al tessuto viola con motivi simili a saette che Emily aveva comprato per farne un vestito. Michael si è appassionato all’idea e ha realizzato un abito attraversato da una trama di fulmini”. Ma forse l’eredità più grande che Emily lascia ai suoi lettori, nella ricerca di Frances O’Connor come nel suo intramontabile capolavoro, la ascoltiamo per ben due volte nel film: “C’è solo una vera felicità in questa vita, amare ed essere amati”. Samantha De Martin, Arte.it

22 agosto 2023
Si riaccendono le luci dell'Oberdan con un bel film tratto da Pavese
La forza di Cesare Pavese è nella descrizione dei personaggi. Piccoli nitidi dettagli che fanno vivere sulla pagina uomini e donne. Nel caso de La bella estate, soprattutto donne, visto che è uno dei più noti romanzi "al femminile" dello scrittore piemontese. E chi meglio di una regista per portarlo sul grande schermo? Di fronte a tale impresa Laura Luchetti trova una chiave di lettura efficace. A creare il caso è la presenza di Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, qui al debutto sul grande schermo nel ruolo di Amelia. Quanto Amelia, nella volontà di Pavese e Luchetti, è sfuggente e misteriosa, quanto Ginia, la vera protagonista, è radicata nel presente, divisa tra l'impiego come sarta e i lavori domestici per accudire il fratello Severino. A interpretarla è Yile Yara Vianello, già vista in Corpo celeste e La chimera di Alice Rohrwacher.

13 giugno 2023
Essere e avere: uno sguardo favolistico e poetico sul mondo dell’infanzia
Indugiando sulla solitudine dell’alunno nel suo lavoro e sulle relazioni maestro-alunno e alunno-alunno, Philibert traduce visivamente le emozioni infantili, e, in particolare, suggerisce il percorso interiore che spinge il bambino a confrontarsi con se stesso e con gli altri. Apprendere a vivere in un ambiente comunitario, misurandosi coi propri compagni, significa, innanzitutto, imparare a rispettare la singolarità e la diversità altrui. Sono queste le basi di una vera democrazia, in cui le aspirazioni individuali si coniugano con le esigenze della collettività e il rispetto della dignità dell’uomo. La scuola di Lopez diviene il modello di una comunità dai principi repubblicani, spazio ideale per la costruzione di un pensiero libero e la formazione di individui autonomamente pensanti. Qui, i bambini maturano e crescono, sotto l’ala protettrice del maestro, per arrivare al traguardo finale, costituito dal passaggio al collegio. Il piano-sequenza contribuisce a restituire il mistero della loro crescita, mostrando, con pudore, la gravità del divenire di un’età. Gli alunni, piccole tartarughe alla scoperta della realtà, si formano in una scuola che conserva ancora, per Philibert, il significato originario che i Greci le avevano attribuito: la scuola di oggi, custode della skolé del mondo antico, resta il luogo del “tempo libero”, spazio insostituibile destinato a curare l'”essere” e l'”avere” dell’uomo nel mondo.
Sonia Giardina, Sentieri Selvaggi

13 giugno 2023
ALMODÓVAR - LA FORMA DEL DESIDERIO
Cinque film di culto in versione restaurata per riscoprire la dirompente attualità e la libertà espressiva del cinema di Pedro Almodóvar degli anni ’80.
Negli anni ’80 Almodóvar conquista la scena internazionale film dopo film con la forza di un ciclone: il suo cinema estroso e coloratissimo rappresenta la reazione ai rigidi schemi sociali e morali ereditati dal franchismo; riesce ad essere dissacrante attraverso una miscela unica di realismo e fantasia che rivoluziona il linguaggio cinematografico di quegli anni, introducendo temi considerati scabrosi e trasformando donne, poveri ed emarginati in eroi ed eroine di un mondo nuovo, sgangherato e kitsch ma pieno di energia e politicamente molto, molto scorretto.
Esattamente 40 anni fa L'indiscreto fascino del peccato suscita grande scalpore e accende il dibattito alla Mostra del cinema di Venezia del 1983; con la commedia noir Che ho fatto io per meritare questo? il giovane Almodóvar va alla ricerca di quello che si cela dietro la facciata di una tranquilla famiglia spagnola; indimenticabile melodramma dei sentimenti, La legge del desiderio, con un giovanissimo Antonio Banderas, vince il Teddy Bear al Festival di Berlino nel 1987 e rivela per la prima volta il regista spagnolo a un pubblico italiano sbalordito e pronto a lanciarne il culto; Almodóvar torna a Venezia con Donne sull’orlo di una crisi di nervinel 1988, la commedia degli equivoci che con oltre 50 premi, una nomination agli Oscar® e record al Box Office di più paesi, consacra a livello internazionale il talento del regista spagnolo; con il giallo sentimentale e famigliare Tacchi a spillo (1991), il cinema di Almodóvar continua a graffiare, riprendendo le tematiche e l’estetica degli anni ’80 e aprendosi allo stesso tempo verso una nuova fase creativa.
Questi film rappresentano una cinquina perfetta per leggerezza, spavalderia, audacia e capacità corrosiva. Una rassegna imperdibile a un prezzo imperdibile: solo 3,50 euro a film!

08 giugno 2023
As Bestas: il nuovo straordinario film di Sorogoyen e la sua etica spietata
In As Bestas il carattere pericolosamente soggettivo della giustizia naturale e il principio plautino dell’homo homini lupus vengono portati all’estremo e – come già nella filmografia passata di Sorogoyen – la convinzione più o meno lecita del sopruso trasforma la ‘vittima’ in carnefice. Saranno solo i fattori ambientali e i fortuiti casi della vita che decideranno chi con la morale saprà frenare l’istinto, e sarà la caoticità degli eventi a sentenziare chi, tra intelletto e bestialità, avrà la meglio.
Il casting del film, nel costruire questa dicotomia, è brillante: i volti, la fisicità e le interpretazioni degli attori (tutte eccellenti, nessuna esclusa) amplificano questa opposizione quasi esistenziale, senza però scadere nella bidimensionalità e anzi insistendo sulle ambiguità e le sfumature di ogni maschera. Il regista ci cala in una fanghiglia dell’anima, ma pur senza cedere al politicamente corretto non manca di suggerire una flebile luce in fondo al tunnel. Parliamo dei personaggi femminili, gli unici capaci di bilanciare la ferale vendicatività degli uomini.
As Bestas, lavoro eccellente cui veramente pochissimo può essere rimproverato, è la definitiva consacrazione di un regista e sceneggiatore il cui vivido talento meriterebbe una fama ben più importante. Autori come Rodrigo Sorogoyen, che riescono a mantenere intatto il loro stile e il livello qualitativo delle proprie opere pur cambiando continuamente genere, sono merce estremamente rara. Nell’omologazione che sempre più piaga il cinema contemporaneo e nella debolezza di un cinema europeo troppo spesso ripiegato su se stesso, i film di questo impeccabile regista spagnolo sono un patrimonio da difendere con le unghie e con i denti.
Giuseppe Sallustio, Anonima Cinefili

07 giugno 2023
Animal House di John Landis: Toga! Toga! Toga!
Animal House, dietro il paravento di mille sconcezze quasi infantili, è in realtà un film scopertamente politico: il ventisettenne Landis guida una ciurma di pirati assai numerosa (c’è anche il quasi esordiente Tom Hulce) tra i quali spicca il bucaniere per eccellenza, John Belushi. “Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare”, eccola la summa del pensiero dei Delta. Distruggere tutto, perché tutto è in realtà già distrutto, e solo imbellettato come i cadaveri decomposti che devono arrivare comunque decorosi al funerale. Spassoso come pochi film a lui coevi, radicalizzazione dell’idea primigenia di M*A*S*H, Animal House è una furibonda orgia rabelaisiana nel cuore ancora “puro” dell’America. Landis, che non ama la fiera delle crudeltà fine a se stessa, contribuisce a costruire personaggi a tutto tondo che sulla carta hanno in realtà il tratto iconoclasta della vignetta satirica (si pensi anche solo ai nomi dei personaggi “cattivi”: Wormer, DePasto, Marmalard, Neidermeyer). In questo modo dona una complessità psicologica e narrativa a un materiale che rischiava di essere a uso e consumo della battuta grezza, o dell’escatologia, territori in cui si limiteranno a muoversi molti epigoni del film. Qui invece il corpo putrescente dei peggiori studenti del Paese si ritrovano a combattere, a colpi di brufoli esplosi e sconcezze d’ogni tipo, il perbenismo della Camelot di Kennedy. Inno anarchico come pochi, Animal House testimonia la libertà espressiva di Landis, il suo amore per il cinema classico, la sua erudizione, la passione per la distruzione (la sarabanda finale è imperdibile e lascia sempre a occhi spalancati per la perfetta geometria dello spazio e del tempo delle inquadrature) e per la cultura e la musica nera, che proromperà nell’immediatamente successivo The Blues Brothers. Se parte della critica restò fredda, forse spaventata da un furore così ludico e belluino a un tempo, il pubblico comprese da subito il potere rivoluzionario del film, e affrontava le proiezioni pronto a lanciare per aria il cibo e a rispondere al grido di battaglia più improbabile di tutti i tempi: Toga! Toga! Toga!
Raffaele Meale, Quinlan

30 maggio 2023
RIAPRIAMO CON UN FILM SPLENDIDO!
Dopo uno stop forzato di 3 giorni per motivi tecnici, stasera riapriamo!
Siamo contentissimi.
Riapriamo con un film speciale: Il respiro della foresta.
Un maestoso viaggio, con immagini di grande impatto visivo, che racconta l’annuale ritiro di migliaia di monache. Anziane e giovani, nei giorni più freddi dell’anno si auto-confinano in piccole abitazioni in legno su un altopiano battuto dal vento. È un film che ci avvicina al tema della fede in modo profondamente spirituale e al tempo stesso ci fa scoprire uno dei luoghi più affascinanti e remoti nel mondo.

28 maggio 2023
CHIUSURA TEMPORANEA DEL CINEMA
Purtroppo, ieri sabato 26 maggio, per motivi tecnici abbiamo dovuto annullare le proiezioni.
Oggi, domenica 27 maggio, la situazione è rientrata ma dobbiamo fare verifiche . Oggi e domani le proiezioni sono annullate.
Non preoccupatevi, i film li riprendiamo il prossimo weekend.
Guardate il sito per gli aggiornamenti.

25 maggio 2023
Il respiro della foresta, una rappresentazione visivamente potente della realtà vissuta sotto il regime totalitario
Il respiro della foresta esplora il concetto buddista per cui tutte le cose fisiche e mentali nascono, crescono, si sviluppano, decadono e muoiono, così come succedeva per Primavera, estate, autunno, inverno…e ancora primavera (2013), l’apologo morale sulla ciclicità di Kim Ki-Duk, anche se ad avvicinarsi maggiormente è Baraka (1992), un film documentario diretto da Ron Fricke, che fu direttore della fotografia in Koyaanisqatsi, il primo film della trilogia qatsi di Godfrey Reggio.
Il documentario, visivamente accattivante, offre una prospettiva stupefacente sul rigido clima tibetano e segue circa 7.000 monache buddiste tibetane che si rifugiano in capanne di legno di fortuna per un ritiro di 100 giorni che si svolge durante la parte più fredda dell’anno. La prima parte è molto evocativa e pone l’accento su dettagli fondamentali della vita monastica: le monache durante le assemblee religiose, la preparazione dei pasti, le visite mediche, l’interazione con i loro guru o la pratica della meditazione. Il pubblico viene coinvolto in una serie di scene che illustrano le varie attività delle monache, da una che disegna un’immagine di Buddha durante un sermone a un’altra che lecca una ciotola dopo il pranzo. Queste e molte altre scene formano una sequenza visiva di eventi eterogenei, che ritraggono le monache in un’immagine di semplicità, docilità e ingenuità. Agli spettatori de Il respiro della foresta non resta che ammirare lo spettacolo delle immagini che Jin Huaqing mette in scena raccontando un tratto profondo della Cina, vero ieri come oggi.
Matteo Di Maria, SentieriSelvaggi