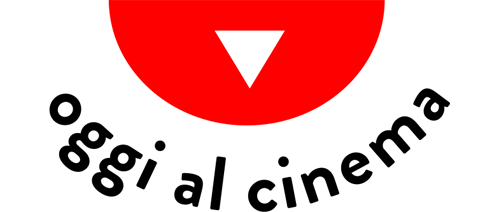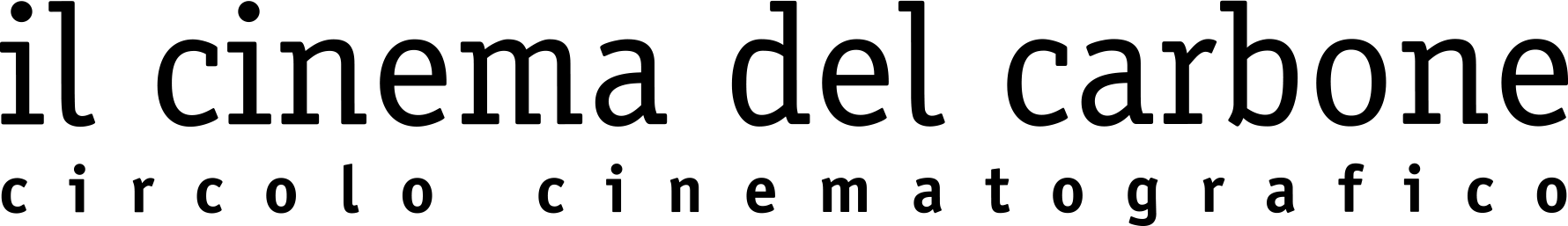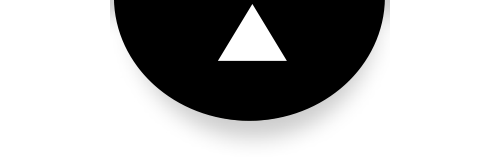10 novembre 2023
Domenica 12 novembre festeggiate con noi la Giornata europea del cinema d'essai
Domenica 12 novembre 2023 la CICAE, in collaborazione con il network Europa Cinemas organizza per l'ottava volta la GIORNATA EUROPEA DEL CINEMA D'ESSAI: il cinema del carbone sarà presente assieme ad altri 700 cinema in più di 40 paesi, per celebrare l'importanza delle sale e della produzione artistica del vecchio continente.
I cinema sono presidi culturali nevralgici che arricchiscono ovunque le comunità – nelle città e nelle province. Sono luoghi d’incontro e scambio che uniscono le persone indipendentemente dall’età, dall’origine, dall’istruzione o dal reddito.
Con oltre 100 milioni di utenti ogni anno solo in Europa, i cinema d’essai giocano un ruolo cruciale nel promuovere la diversità culturale e nel dare visibilità ai nuovi talenti.
Per questa giornata di festa ci troverete aperti dalla mattina alla sera: si parte col matinèe del documentario La macchina fissa di Emilio Neri Tremolada (ore 11), presentato dal regista e dal protagonista e seguito da un buffet, per poi proseguire con la tripla proiezione di Club Zero della regista austriaca Jessica Hausner (ore 16 - 18.15 - 20.45).
Vi aspettiamo per festeggiare insieme.

07 novembre 2023
Club Zero di Jessica Hausner: una nuova satira gelida e sofisticata del modernismo occidentale
Allieva di Haneke, con cui condivide lo stesso territorio estetico, e autrice di un cinema crudele e personale, non ha perso il suo tocco per la magnificenza formale delle inquadrature, dei colori e dei suoni che confondono sovente le tracce delle sue intenzioni. Tutto nei suoi film è un segno. In un décor sgombro, i rari accessori lampeggiano come allarmanti indizi, e dentro quadri di maniacale precisione, conduce un nuovo esperimento sociale, ispirandosi liberamente al respirianesimo, la 'disciplina' di chi vive senza mangiare.
I suoi protagonisti si nutrono di aria e di luce, incarnando una forma di assurdità contemporanea in un campus privato che brilla come una moneta nuova. In quello spazio geografico e temporale indefinito, i muri sono verde guano, gli arredi moderni, la moquette arancione. La rigorosa estetica geometrica è in linea con l'istruzione che viene impartita, un discorso igienista ed ecologista che seduce gli studenti (mangiare bene, mangiare meno per preservare la propria salute), prima di legarli a filo doppio a una credenza settaria delirante (non mangiare più per conquistare la giovinezza eterna). Manipolati senza trovare resistenza, i discepoli, tutti ricchi e viziati, vengono progressivamente sottratti all'amministrazione scolastica e all'autorità dei genitori. [...]
Tra humour freddo e crudeltà formale, Jessica Hausner punta il dito su le derive contemporanee: le dottrine pericolose e la sfiducia nella scienza. E a questo punto il problema di Club Zero risiede nel suo tono beffardo e fasullo, che si prende costantemente gioco dei suoi personaggi e serve una morale reazionaria sulla stupidità umana, su una (neo)borghesia incapace nel suo isolamento di classe di interessarsi a d'altro che a se stessa. Regista dell'invisibile e del fuori campo, questa volta si avvicina al più estremo dei campi off, la fede, l'aldilà, la morte.
Marzia Gandolfi, Mymovies

02 novembre 2023
Dirty Difficult Dangerous: Una storia d’amore al confine tra sogno e realtà
È un inno alla speranza il film di Charaf, che ci porta nel Libano dei sopravvissuti. I suoi protagonisti, Mehdia e Ahmed, sono due persone sopravvissute a povertà e guerra. Lei, Etiope, è stata comprata da un’agenzia, trasferita in Libano e portata in una casa dove si occupa, giorno e notte, di accudire un uomo ammalato di demenza. Lui, sopravvissuto a una bomba, è riuscito a scappare dalla Siria ma ora vive di stenti. Eppure entrambi, nonostante passato e presente difficili, non si abbandonano alla tristezza. Il loro legame, vissuto quando possibile, rubando baci per strada e momenti intimi in luoghi di fortuna, è il motore che dà loro la forza per credere in un futuro migliore.
«Ho voluto raccontare l’incontro di due angeli caduti, Ahmed e Mehdia, due emarginati costretti ad affrontare quotidianamente pericoli e discriminazioni razziali – ha dichiarato il regista Wissam Charaf – Un melodramma in cui crudeltà, commedia e tenerezza si intrecciano, offrendo una visione intima della società libanese odierna».
Simona Grisolia, Taxidrivers

24 ottobre 2023
Un'Odissea contemporanea: Io Capitano di Matteo Garrone
Matteo Garrone evita la didascalia di denuncia e il patetico grossolano e ne trae piuttosto un racconto persino solare, luccicante di speranza, commovente solidarietà tra disperati e bisogno di futuro, quasi un classico e avventuroso racconto di formazione, dalla sventatezza alla maturità, sino alla prima assunzione di consapevolezza. Se la sceneggiatura (firmata da Garrone, Massimo Gaudioso, Andrea Tagliaferri e Massimo Ceccherini, proprio lui, il comico!) appare curata e ben strutturata nel suo percorso a stazioni (come del resto lo è tutta la filmografia Garroniana), le ambientazioni sono di un colorato realismo di sensuale visione, ma soprattutto si coglie il piacere evidente del regista romano nei confronti del colpo di scena magico che sposta improvvisamente i piani della lettura (corpi che vincono la forza di gravità, esseri fantastici, stregoni che ci azzeccano), sino a suggerire una dimensione trascendente di favola contemporanea. D'altra parte, tutta l'effervescente filmografia di Garrone rimbalza tra i due estremi di un realismo a volte anche acre, plumbeo, magari di argomento criminale e le suggestioni gioiose della meraviglia e della fantasia: da Terra di mezzo, 1996, al Pinocchioterragno e umoroso del 2019.
Massimo Lastrucci, Cineforum

20 ottobre 2023
Foto di famiglia
|

17 ottobre 2023
Foto di famiglia: una toccante storia vera che ha conquistato oltre un milione di spettatori in Giappone
Diretto da Ryôta Nakano, già regista di Her Love Boils Bathwater, Foto di Famiglia si ispira alla divertente e toccante storia vera del fotografo Masashi Asadae alla sua straordinaria capacità di catturare non solo immagini, ma anche i sogni e le speranze di molte famiglie.
Un percorso quello di Masashi che lo porta dall’essere un fannullone conclamato a fotografo affermato e stimato, specializzato nel ritrarre in modo originale non solo la sua famiglia, ma anche altre famiglie, regalando loro preziosi ricordi di vita.
Una narrazione quella di Foto di Famiglia in cui fa da sfondo anche il drammatico terremoto del 2011 in Giappone che mette in pausa la carriera di Masashi ma che lo porterà a decidere di unirsi a un gruppo di volontari in un’impresa straordinaria, quella di recuperare le foto e gli album di famiglia smarriti durante il terremoto e restituirli ai legittimi proprietari. Oltre 60.000 foto saranno restituite ai proprietari grazie allo splendido lavoro dei volontari di cui Masashi fa parte e il racconto di questa incredibile impresa fa il giro del mondo.
Foto di Famiglia è un film che parla del potere della fotografia capace di catturare immagini, ma anche emozioni e aspirazioni. È una storia vera di speranza, resilienza e solidarietà in un momento di profonda crisi. La capacità di Masashi Asada di riportare il sorriso sui volti delle persone attraverso la sua arte è un messaggio potente di quanto la creatività e la gentilezza possano influenzare positivamente le vite degli altri.
CultureTherapy

12 ottobre 2023
Sugar Man: l'incredibile storia di Sixto Rodriguez
Sono passati dieci anni da quando Sugar Man arrivò a vincere un meritato premio Oscar come miglior documentario, e fece il suo debutto nelle sale italiane per la prima volta. E oggi, dieci anni dopo, il tempo trascorso ha contribuito ulteriormente a aumentare il fascino del film, e ancora di più quello che circonda i suoi interrogativi principali. [...]
La storia di Sugar Man e quella di Rodríguez sembrano puntare dritti i loro segnali verso il rapporto e la relazione degli artisti con il successo, il denaro, la vita e la morte. Ognuno è libero di leggere i fatti del film e quelli successivi come vuole, ovviamente, ma le riflessioni più rilevanti che emergono dal film appunto queste: quelle che riguardano il modo in cui ogni uomo decide di condurre la propria vita, e dove e come riesce o non riesce a dare senso all’esistenza.
Per tutto il resto, ci sono i dischi e la musica di Rodríguez, dolenti, poetici, politici, vicini in maniera personale a Dylan come a Cat Stevens, e soprattutto e direttamente alla realtà di Detroit. La metropoli che, oggi, è nella storia non più per essere stata Motor City, il centro dell’industria automobilistica americana e mondiale, ma quella che è stata protagonista di uno spettacolare default, divenuto simbolo degli anni della crisi post-subprime, e il cui attuale rinascimento va a formare un altro curioso e casuale (?) parallelo con la storia personale di Sixto Rodríguez, il musicista che ha dovuto fallire per arrivare a risorgere. Un uomo che, a modo suo, è stato e rimane un mistero indecifrabile.
Federico Pontiggia, CominSoon

03 ottobre 2023
Kafka a Teheran: le devastazioni psicologiche del regime in Iran attraverso tableau vivants di vita quotidiana
“Più grande è il budget più piccole sono le idee, più piccolo è il budget più grandi sono le idee”.
Ci perdonerà Francis Ford Coppola per lo scippo, ma l’impressione è che la coppia iraniana Asgari, Khatami lo abbia preso alla lettera. Registi e sceneggiatori che, per necessità, per disperazione ma anche per convinzione hanno cesellato unfilm clandestino, dalla produzione lampo, dalla troupe scarnificata, già costato loro la libertà. Nel pericolo di ingerenze, nella ristrettezza di mezzi, i due autori nascondono sotto il velo del sarcasmo e dell’assurdo kafkiano, un J’accuse arguto e lucidissimo conto il regime iraniano.
Cinema come finestra su una realtà disperata, dunque, in bilico tra il dramma e la farsa, tra il paradosso e il grottesco. Dodici storie di repressione unite da una scrittura tutta dialogica, sempre vibrante nei ritmi, e filmate da una (sola) camera fissa per dodici long takes.
A volte sono piani americani, altre primi piani. Comunque si ripropone un duello tra campi e controcampi mai mostrati, sempre allusi e uditi. Una gabbia al visibile e all’agibile che allegorizza, si capisce, quella che regna fuoricampo, fuori sala: teocratica, onnipotente o implacabile proprio perché invisibile. A segnalarcela è la voce o-scena (non solo etimologicamente) di burocrati, passacarte, censori della libertà. Sono anonimi esecutori. Depensanti che applicano la legge e attuano l’assurdo. Inutile sottolineare, però, che le vittime che guardano in camera, incalzando loro, vedono noi. [...]
Schematicità (allegorica) di stile, denuncia sociale, essenzialità di scrittura, naturalezza di recitazione: tutto brilla, sgomenta e indigna nel film della coppia Asgari-Khatami passato a Cannes 2023.
Davide Maria Zazzini, Cinematografo.it

21 settembre 2023
Manodopera, una bellissima sorpresa da non perdere
Non fatevi sfuggire questo film: è la più bella sorpresa di questo inizio di stagione. È vero che è un film d’animazione (a passo uno, con i pupazzetti, come quelli di Wallace e Gromit) ma qui non c’è niente (o quasi) da ridere, piuttosto c’è la malinconia e la delicatezza con cui il regista ricostruisce la storia dei suoi nonni, emigrati all’inizio del secolo dal Piemonte alla Francia.
Ughetto come lui, la famiglia di Luigi e Cesira impara a cercare il lavoro dove lo si trova, per esempio al di là del confine italiano, all’inizio lasciando moglie e figli piccoli a casa, poi facendosi seguire da tutti. Intanto gli Ughetto fanno i conti con la guerra di Libia, poi la Grande guerra, la fame, gli incidenti sul lavoro, i fascisti…
Ogni tanto la mano del regista entra in campo, a sottolineare il senso del racconto che il film si è proposto di fare (ricostruire la storia dei nonni), ma soprattutto per aumentare quella dolcissima ma non meno veritiera ricostruzione di un mondo ormai scomparso eppure ancora così pieno di verità e di significato.
Senza nostalgia (il titolo originale Interdit aux chiens et aux italiens non ha bisogno di traduzione) ma con tantissimo amore. Per chi vuole trovare la poesia dell’animazione a passo uno.
Paolo Mereghetti, IoDonna

20 settembre 2023
Strange Way of Life: Ethan Hawke, Pedro Pascal e lo strano western di Pedro Almodóvar
«Strange Way of Life è un western queer, nel senso che ci sono due uomini e si amano e si comportano in modo opposto nella stessa situazione. Riguarda la mascolinità in senso profondo perché il western è un genere maschile. Quello che posso raccontarvi del film è che ha molti elementi del western: ha il pistolero, ha il ranch, ha lo sceriffo, ma ciò che la maggior parte dei western non ha è il tipo di dialogo. Non credo che un film western abbia mai raccontato l’incontro tra due uomini. Lo strano modo di vivere a cui fa riferimento il titolo allude al famoso fado di Amalia Rodrigues i cui testi suggeriscono che non esiste esistenza più strana di quella che si vive voltando le spalle ai propri desideri».
Pedro Almodóvar